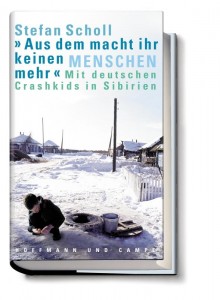Archive for August, 2009
Mantegna: una mostra di successo
26 Aug 2009In silenzio, in ammirazione. Una donna fissa per lunghi minuti “La Sacra famiglia” di Andrea Mantegna. La mostra sul Rinascimento italiano è l’evento clou dell’anno al museo capitolino Pushkin. Un fiume di gente, soprattutto giovani, riempie le sale quasi tutti i giorni, ma nei fine settimana le file si allungano. La luce fioca cade sul quadro del maestro veneto in un ambiente sostanzialmente buio. Lo sfondo rosso delle pareti contribuisce a rendere l’atmosfera unica.
Il quadro del Mantegna era atteso con impazienza, poiché non vi sono sue opere nei musei russi. Particolare il destino di questo capolavoro. Dal 1945 al ’55 fu conservato proprio al Pushkin. Qualche mese prima di riconsegnarlo ai legittimi proprietari del museo di Dresda i russi organizzarono una mostra durata 5 mesi. “Ben 1,2 di visitatori – ricorda l’attuale direttrice del Pushkin Irina Antonova – vennero a vedere i tesori che sarebbero stati restituiti ai tedeschi”.
Ecco, quindi, in parte spiegata la grande attesa per godersi dal vivo questo capolavoro in olio della fine del quindicesimo secolo. Sue gigantografie capeggiano all’entrata di una delle gallerie più importanti del mondo. Alla biglietteria non si parla d’altro. Qualcuno sale di corsa una ripida scalinata di marmo, mettendo a dura prova il proprio fiato. Subito dopo lo stacco del tagliando d’ingresso il visitatore resta senza parole. La sala con il capolavoro è giusto di fronte, a qualche decina di metri, con quella saggia luce che illumina la meraviglia del Mantegna.
Farsi largo fra i tanti presenti e guadagnarsi una buona posizione d’osservazione non è facile. Bisogna attendere una manciata di minuti, rischiando qualche inavvertita spallata.
Il bambino in primo piano attrae subito l’attenzione. Il gioco dei colori lo mette ancor più in risalto rispetto alla sua naturale centralità nella rappresentazione. Ma tutte le figure, proposte su uno sfondo nero astratto, sono assolutamente a sé stanti. Il maestro veneto ottiene la concentrazione assoluta sull’uomo, che, come viene evidenziato dagli organizzatori della mostra, “è il maggior Dio dell’epoca del Rinascimento”. La tragica tensione di Giuseppe, la silenziosa pacatezza davanti alla sofferenza di Elisabetta (la madre di Giovanni Battista), il conquistante sentimento materno di Maria e la tranquillità infantile del Cristo, asseriscono i critici del Pushkin, non hanno analoghi nell’arte del suo tempo.
Mantegna (1461 – 1506) viene considerato il più “tragico e coraggioso” artista del primo Rinascimento italiano. Il suo amore per la civiltà latina è palese anche in questo capolavoro: il viso di San Giuseppe si avvicina a quello dei ritratti eroici sculturei del periodo della repubblica romana. I colori utilizzati creano un’espressione speciale di sentimento: solennità, gloria, ma anche dolore. Il restauro nel 2001 al J.Paul Getty Museum di Los Angeles ha davvero riconsegnato al capolavoro del maestro veneto tutte le sue splendide caratteristiche originali. Un fine vetro lo difende da flash fotografici e possibili attentatori.
Intorno al “La Sacra famiglia” sono posizionate opere di altri artisti rinascimentali quali ad esempio di Simone Martini, Dosso Dossi, Veronese, Vasari, Perugino. E’ un semplice assaggio che lascia comprendere la grandezza del Rinascimento italiano. I visitatori si accalcano anche intorno a queste bellezze alla ricerca del segreto di tali meraviglie.
L’amore dei russi per l’arte è un sentimento da sempre conosciuto. La collaborazione con gemelle istituzioni internazionali rende possibile l’organizzazione di mostre di così alto valore. In autunno il “Pushkin” si sdebiterà inviando un proprio capolavoro alla “Gemaldegalerie” di Dresda. La scelta è caduta su “La Sacra Famiglia e San Giovannino”, una tempera su tavola di Agnolo Bronzino. Il Rinascimento italiano impazza proprio nei musei di mezza Europa.
Primavera – Estate 2009
Bolshoj: la lenta ricostruzione
26 Aug 2009“La ricostruzione del Bolshoj inizierà dal mese di maggio, ma l’edificio centrale verrà chiuso dal primo luglio 2005. I lavori finiranno entro marzo-aprile 2008. Questo tipo di intervento si era reso necessario da tempo e non si poteva più rimandare”. Anatolij Iksanov, direttore del teatro, ci ha accolto con squisita gentilezza nel suo ufficio. Da mesi è al centro di continue bufere. Il presidente Putin ha compiuto un sopralluogo per rendersi conto di persona della situazione. Il Bolshoj è uno dei simboli della Russia.
“La prima tappa della ricostruzione – ci spiega A.I. è già finita nel 2002, quando il 29 novembre dello stesso anno abbiamo aperto il secondo palcoscenico del Bolshoj e uno spazio per le prove. Adesso inizia la seconda tappa”.
Se i turisti stranieri verranno a Mosca in estate potranno ancora vedere il teatro? “Fino al primo luglio sì. Potranno sia visitare il palazzo del Bolshoj che vedere gli spettacoli. Dopo, potranno venirci a trovare al nuovo edificio che funzionerà regolarmente per i tre anni previsti per la ricostruzione di quello storico”.
Quali problemi avete incontrato per definire il progetto di ammodernamento del teatro. “Il nodo principale è stato quello di conciliare gli interessi per il mantenimento del palazzo come monumento architettonico e rendere possibile l’utilizzo delle tecnologie contemporanee per i teatri”.
Avete preso in esame le esperienze della Scala di Milano o la Fenice di Venezia? “Conosco le realtà della Scala, del Convent Garden, dell’Operà di Parigi. Ovunque, sono stato, ho visto ed ho analizzato. Il teatro Bolshoj è in un’altra situazione. Alla Scala vi è stata la possibilità di riunire il palazzo con l’edificio affianco e con un’altra torre. Non voglio giudicare. Tante sono state le discussioni. Al Convent Garden è avvenuto lo stesso: è stato occupato un edificio limitrofo. Al Bolshoj non si può intervenire in quel modo. Non possiamo mutare la vista qui intorno”.
Ed allora? “Possiamo solo guadagnare spazio allargandoci in basso per risolvere i problemi tecnologici. Sotto terra. Non c’è altra via uscita. Dietro al teatro ci sarà una zona pedonale. Sei istituti hanno lavorato per fornire soluzioni. Fin dal 1856, quando il teatro fu ricostruito dopo l’incendio vi sono stati problemi con le fondamenta. Per 150 anni sono stati un vero grattacapo e costantemente sono state rafforzate. Nel 1902 vi fu un piccolo cedimento tanto che la gente non riuscì ad uscire dalle logge. Negli anni ’50 si è persa un po’ di acustica. Ora si pone il problema di fare delle fondamenta che durino per 200 anni”.
Da quanto si apprende da fonti ufficiali e giornalistiche questa ricostruzione costerà tantissimo allo Stato russo. Si parla di cifre astronomiche. “Il progetto completo ha un costo calcolato di 25 miliardi di rubli (ndr. circa un miliardo di dollari). Lo Stato stanzierà una somma pari a 15 miliardi. Dobbiamo fare quindi riferimento a questa seconda cifra”.
Ma gli sponsor privati non contribuiranno? “I soldi degli sponsor servono per gli spettacoli e per la compagnia”.
In futuro, quale sarà l’immagine che darà il teatro Bolshoj di sé nel mondo? “Ritengo che rimarrà il maggior teatro d’opera russo”.
Che differenza esiste tra il Bolshoj ed il Mariinskij (ex Kirov) di San Pietroburgo, diretto da Gergiev? “Noi per un 60% rappresentiamo repertorio russo, mentre i pietroburghesi sono più orientati verso la cultura europea”.
Quest’anno avete proposto nel vostro tabellone un’opera moderna, un po’ diversa dal solito “I figli di Rosental”. Tante sono state le polemiche. “Sono contento che, per la prima volta dopo 30 anni, siamo riusciti a rappresentare un’opera che il teatro ha direttamente prenotato ad un artista ed ha compiuto il suo regolare corso. Un genere non si può sviluppare senza ordini nuovi. Sono contento delle tante discussioni sull’opera. Il prestigio di uno Paese dipende molto dal suo teatro. La Scala è l’Italia, L’Opera di Vienna è l’Austria. Il Convent Garden è la Gran Bretagna”.
La polemica intorno a “I figli di Rosental” è stata forte. “Tutte le opere nuove hanno difficoltà ad imporsi al pubblico ed alla critica. Anche il “Boris Godunov” nel 19esimo secolo ebbe un mucchio di critiche. La prima de“Il lago dei cigni” di Ciakovskij fu un disastro. Purtroppo, per la gente un’opera diventa un classico dopo decenni o dopo la morte dell’autore. Non ci sono profeti in Patria, si dice in Russia. Il Bolshoj non è un museo. La sua missione è lo sviluppo del balletto e dell’opera”.
Alcuni deputati hanno duramente criticato l’autore Sorokin ed il suo lavoro. “E’ solo ignoranza. L’1% della gente va a teatro. I deputati vogliono farsi pubblicità. Sarebbe stato meglio che perlomeno avessero letto il libretto. Il Bolshoj è uno dei simboli della Russia. Se fossero state organizzate le stesse cose per un altro teatro nessuno ci avrebbe fatto caso”.
Certo che i soldi per la ricostruzione sono enormi “Ho già detto che le due cose possono essere associate. Sono tanti gli interessi in comune”.
E come vi siete tutelati? “Fin dal principio ho affermato il principio che i soldi della ricostruzione devono essere gestiti da altri non dalla direzione del teatro. Non vogliamo avere nemmeno un copeco in mano. Io non sono un costruttore. Mi si può imbrogliare facilmente. Noi rappresentiamo spettacoli e verificheremo come va avanti il progetto. Il controllo rimane a noi”.
Non c’è un tentativo dall’alto di imporre una linea alla cultura? “A San Pietroburgo una compagnia è stata denunciata per aver messo in scena il Revisore di Gogol in una forma non classica. Mi chiedo se sia una tendenza generale o la stupidità di alcune persone singole. Io ritengo che sia fondata la seconda ipotesi. Anche se ci sto riflettendo da tempo. Qui al Bolshoj è venuto Putin, che ha visto i manifesti de “I figli di Rosental”. Non ha detto niente. Non c’è alcuna reazione ufficiale. Solo l’arte libera può dare aria alla società. In Russia il teatro è sempre stato una tribuna dove si poteva parlare in modo emozionale di cose che creavano problemi in politica. “I figli di Rosental” è un’opera per la società”.
Giuseppe D’Amato
Riconsegna proprietà confiscate
26 Aug 2009 La ruota della storia, a volte, torna indietro. Presto la Chiesa ortodossa russa potrebbe rientrare in possesso di quasi tutte le sue proprietà confiscate dai bolscevichi dopo la Rivoluzione d’ottobre del 1917. Questo almeno prevede un controverso progetto di legge (pdl) del ministero dello Sviluppo economico, in discussione in marzo, scovato dall’autorevole quotidiano finanziario “Kommersant”. Il governo intende disfarsi di beni che gravano pesantemente sul bilancio dello Stato.
La ruota della storia, a volte, torna indietro. Presto la Chiesa ortodossa russa potrebbe rientrare in possesso di quasi tutte le sue proprietà confiscate dai bolscevichi dopo la Rivoluzione d’ottobre del 1917. Questo almeno prevede un controverso progetto di legge (pdl) del ministero dello Sviluppo economico, in discussione in marzo, scovato dall’autorevole quotidiano finanziario “Kommersant”. Il governo intende disfarsi di beni che gravano pesantemente sul bilancio dello Stato.
Se l’operazione andrà in porto la Chiesa ortodossa diventerà, come ai tempi dello zar, il più grande proprietario mobiliare ed immobiliare del Paese, rivaleggiando in ricchezza con la Gazprom e la Società ferroviaria (RzhD).
Secondo alcuni osservatori la crisi economica produce, oggi, perlomeno un atto di giustizia storica. Ma le opinioni sono le più diverse ed in aula alla Duma i deputati, soprattutto quelli comunisti, potrebbero dare battaglia. L’onorevole Vladimir Kashin del Pc giudica questa mossa dell’Esecutivo come un tentativo del duo Medvedev-Putin di riconquistare la fiducia popolare, che vacilla davanti alla crisi. Il presidente ed il premier sono notoriamente ortodossi praticanti. La moglie dell’attuale leader russo, Svetlana, è stata in passato impegnata affianco delle gerarchie ecclesiastiche in numerosi progetti sociali.
La Chiesa ortodossa non se la passa, comunque, affatto male. Attualmente possiede 478 monasteri ortodossi, 13.000 tra chiese e cattedrali, 16.000 parrocchie, 4.696 scuole di catechismo. Nella sola Mosca, dove i prezzi al metro quadro rimangono alle stelle nonostante la recessione, potrebbe aspirare a 600 siti che vanno da 300 metri quadri ad oltre 10 ettari, con edifici fino a 50mila mq. Si calcola che il valore di questi beni immobili si aggiri sui 50 miliardi di dollari. Se si considerano anche i terreni nella capitale gli zeri si moltiplicano in maniera incredibile.
A godere di questa legge dovrebbero essere anche le altre confessioni ufficiali: musulmani, ebrei, buddisti, cattolici.
Dopo il crollo dell’Urss le prime restituzioni di beni religiosi avvennero grazie ad un decreto di Boris Eltsin nell’aprile 1993. Seguì una legge del Parlamento nel settembre 2004. La più clamorosa disputa tra autorità religiose ed enti statali, finita nelle aule giudiziarie, si registrò per un edificio dell’Università Statale Umanistica a pochi passi dal Cremlino. Dopo il periodo sovietico Stato e Chiesa in Russia hanno nuovamente stretto la tradizionale alleanza. Questo pdl è il definitivo suggello.
Febbraio 2009
2009 La “Nuova Europa” al voto
26 Aug 2009Astensionismo di massa, protesta e delusione. E’ questa la “nuova Europa” uscita dalle urne del voto continentale della scorsa settimana. Gli ultimi aderenti ai Ventisette hanno consegnato a Bruxelles tassi di partecipazione allucinanti con partiti xenofobi o anti-europeisti in sensibile crescita. Ma non era l’Est – ci si domanda per l’ennesima volta – ad aver fatto per decenni carte false pur di unirsi alla parte più ricca del Vecchio Continente? Vivere insieme significa dover essere pronti a dei sacrifici. Ed invece il “tutto e subito”, tipico delle culture dei Paesi usciti dall’incubo del comunismo, è un cattivo consigliere.
Un passo indietro è utile a comprendere le ragioni di questa evoluzione negativa. La posizione di partenza nel 2004, anno dell’ingresso di dieci Stati, va tenuta ben presente. Per quelli della Mitteleuropa l’adesione all’Ue è stata soprattutto una fuga da una situazione geostrategica complicata che, per troppo tempo, aveva influenzato negativamente i destini della regione. Per i balcanici, gli ultimi arrivati nel club nel 2007, è solo la speranza di un futuro economico migliore.
Mancano quasi completamente in queste società le classiche concezioni europeistiche, che hanno portato alla costruzione di ciò che abbiamo davanti. Probabilmente Bruxelles corse troppo in fretta ad abbracciare i fratelli meno fortunati dell’Est, non comprendendo a quali rischi politici si andava ad esporre.
Un po’ ovunque, nelle “Seconda Europa”, i partiti al potere hanno preso legnate sonore pagando per la grave crisi economica. Si guardi ad esempio all’Ungheria, uno dei Paesi più colpiti dalla recessione: i conservatori di “Fidesz” hanno ottenuto il 67% delle preferenze ed il partito anti-rom d’estrema destra “Jobbik” porterà ben due deputati a Strasburgo. Lo stesso numero di seggi avrà il bulgaro “Ataka”, che ha basato il suo successo sulla scelta di contrastare l’integrazione turca in Ue.
Posizioni non meno concilianti avranno gli ultranazionalisti slovacchi di SNS con un loro parlamentare. Dalla Polonia giungono notizie rassicuranti per l’Esecutivo liberale di Donald Tusk in lotta con il capo dello Stato conversatore Lech Kaczynski. Il prossimo anno i due leader regoleranno i conti in sospeso alle presidenziali. La sinistra resiste solo in Repubblica ceca ed in Lettonia, dove i comunisti riescono a far eleggere Alfreds Rubiks, per 6 anni in galera per aver tentato di rovesciare il primo governo democratico post sovietico del Paese baltico. Una riflessione è, però, urgente e le cancellerie dei Paesi fondatori, è bene, non la rimandino.
Come è possibile che in tutta Europa ci sia così tanto disinteresse per elezioni così importanti quando ormai è evidente che, al tempo della globalizzazione, il Vecchio Continente potrà dire la sua solo unendo le forze ed andando ad una vera unione politica? Nei singoli Paesi membri si guarda sempre più spesso all’Ue come alla panacea per complessi ed irrisolvibili problemi interni. Ma quali soluzioni forti possono giungere da un’Unione con rappresentanti eletti in alcuni casi da un quinto della popolazione?
Giuseppe D’Amato
Giugno 2009
L’Olimpo dei giusti
25 Aug 2009Natalja Estemirova ha raggiunto Anna Politkovskaja nell’Olimpo dei giusti. Due donne, quasi coetanee, con un coraggio non comune che hanno dato la vita al servizio della verità e della difesa dei diritti umani. La prima: una russa di padre ceceno, insegnante di storia, tele-giornalista locale, attivista di “Memorial” . La seconda: la figlia di diplomatici sovietici di passaporto russo-americano, una reporter instancabile ed incorruttibile.
Tante le similitudini tra loro. La principale è che ambedue rimasero sgomente davanti agli orrori della seconda guerra caucasica, iniziata nell’autunno del 1999. Questa traumatica esperienza fece radicalmente cambiare il corso della loro esistenza. Da qui la volontà di gettarsi anima e corpo nella difesa dei deboli. Chi le ha conosciute racconta di due donne che sentivano di avere una missione da svolgere e che la portavano avanti senza mostrare di avere paura, nonostante le tante disavventure e le continue minacce subite.
Nella spiritualità orientale esiste la figura dei “jurodivye”, in italiano “pazzi per Cristo”: dei “folli” che abbandonavano tutto per l’ascesi religiosa e si attiravano il disprezzo della cosiddette “persone normali”. Spesso, proprio per il loro aspetto di stolti, ai quali viene tollerata una libertà di parola incredibile, essi osano rimproverare i potenti dei loro peccati. Natalja ed Anna assomigliavano ad una versione contemporanea di “pazze per la verità”.
Aver puntato un’arma contro delle donne è un’ulteriore elemento di riflessione. Una terribile novità per il Caucaso come furono, ad inizio decennio, le “vedove nere”, le giovani kamikaze cecene con le cinture dinamitarde sui fianchi.
La collaboratrice di “Memorial” è stata ammazzata con un primo colpo di pistola al petto in segno di disprezzo ed un altro successivo mortale alla testa. La stessa sorte era toccata in primavera a 13 altre donne. La società cecena, fondata sulla tradizione e sull’onore, è rigorosamente divisa in clan. Per secoli il “gentil sesso” ha avuto una posizione subalterna. Le recenti guerre hanno, però, provocato un autentico terremoto.
Dalla pallottola al petto si deduce che l’omicidio della Estemirova dovrebbe essere maturato in un ben preciso ambiente. L’attivista aveva avuto non poca visibilità anche quando si rifiutò di eseguire l’ordine dell’“uomo forte” di Grozny, Ramzan Kadyrov, che imponeva alle donne di girare per strada con un velo sui capelli.
Solo una manciata di persone coraggiose hanno sfilato al funerale dietro alla bara di Natalja Estemirova. Erano quasi tutte donne. Gli uomini, in pratica, non si sono visti. La paura impera in Caucaso settentrionale, dove, dopo la conclusione ufficiale dell’operazione anti-terrorismo, si è registrata, come denunciano le Ong, una vera impennata dei rapimenti e delle uccisioni dei civili. Il classico dopoguerra, insomma, con una lunga scia di sangue. La temuta resa di conti e faide ancestrali hanno avuto la meglio sul precario ordine pubblico.
Due sono le cose: o l’operazione anti-terrorismo non è mai in realtà finita malgrado gli annunci di giubilo del Cremlino; oppure ci si trova davanti a forze deviate all’interno dei poteri locali, come punta il dito “Memorial”.
La fine della guerra ha provocato la parziale chiusura del rubinetto dei finanziamenti straordinari federali in Russia meridionale. Mantenere la tensione alta serve a far scucire rubli al lontano Centro moscovita. La matassa da sbrogliare per il giovane presidente Medvedev si presenta davvero complicata ed in Russia oggi sono in pochi ad invidiarlo.
Giuseppe D’Amato
Bric, il polo delle economie emergenti
25 Aug 2009Sugli Urali è andato in scena il vertice dei capi di Stato del Bric. E’ la prima volta che le quattro economie emergenti – Brasile, Russia, India e Cina – formalizzano la nascita di un qualcosa che non è ancora evidente a cosa possa approdare. Mosca sembra avere le idee chiare: intende puntare a riequilibrare la situazione economica mondiale e a fondare un polo alternativo a quello euro-americano. Non è un mistero che fonti ufficiali federali abbiano discusso pubblicamente per qualche giorno se e quando il rublo potrà diventare una valuta internazionale.
Il ministro russo delle Finanze, Aleksej Kudrin, ha tolto molte delle illusioni ai dialoganti, proponendo lo yuan cinese come la possibile moneta che farà concorrenza in futuro al sempre più barcollante dollaro americano ed all’emergente euro. Ma si sottolinea a Mosca, in futuro, non ora. Cinesi e russi sono pieni di obbligazioni del Tesoro Usa.
Non si vuole dare un’ulteriore colpo alla valuta a stelle e strisce, provocando un effetto boomerang che potrebbe abbattersi su chi ha fatto la prima mossa. La Banca centrale russa ha, tuttavia, già rivisto la composizione delle percentuali delle sue riserve a favore dell’euro sul dollaro.
Sono passati solo 8 anni da quando la Goldman Sachs diede il nome di Bric a queste economie emergenti, che adesso chiedono il passo. Ad Ekaterinburg si è discusso soprattutto di riforma delle istituzioni finanziarie internazionali. Il “quartetto” pretende più spazio ed attenzione a scapito degli americani e degli europei che detengono il controllo dell’Fmi e della Banca mondiale. Il G20 di Londra ad aprile non ha apportato grosse modifiche. Chi voleva una nuova Bretton Woods è rimasto per ora deluso. Per ora, a meno che gli Stati Uniti di Obama non risorgano economicamente come una Fenice e ribadiscono la loro forza finanziaria.
Il Bric prepara il terreno per i prossimi cambiamenti – sperando in vantaggi da monetizzare – anche se rimane un mistero il reale grado di fiducia reciproco. Gli indiani si potranno mai fidare degli invadenti vicini cinesi? I brasiliani non hanno molto più da guadagnare da un’intesa con Washington che da una con Pechino o Mosca?
Il maggior significato del primo vertice del Bric è dunque politico non economico. Fino a che punto si può creare un’alternativa, è la domanda che si pongono i partecipanti e gli esperti. Sugli Urali non è stata prodotta una chiara risposta. I venti, che spireranno sull’economia mondiale nei prossimi mesi, daranno la direzione che il quartetto prenderà.
16 maggio 2009
Cecenia: vince la “pax russa” – primavera 2009
25 Aug 2009Doveva essere una guerra-lampo, genitrice di gloria per tutti, contro dei selvaggi male armati. Ed invece fu il disastro. Dopo 7 decenni di “pax sovietica” il Caucaso è tornato ad essere una delle zone più instabili e pericolose del pianeta. E come sempre accade in queste tragedie è l’umanità ad avere perso.
Sono tante le immagini che si affollano nella mente del cronista ora che ufficialmente, dal 16 aprile 2009, la guerra in Cecenia è finita. Indimenticabili sono gli occhi fieri di Akhmad Kadyrov, l’ex muftì che, ad inizio decennio, abbandonò con coraggio le file dei separatisti per diventare il centro delle strategie vincenti del Cremlino. Semplicemente gigantesca era la sua guardia del corpo, famose per il basso tasso di sopravvivenza con quel incarico. Lo sguardo triste delle adolescenti kamikaze, vestite di nero con ai fianchi le cinture piene di dinamite, ha colmato di orrore il mondo intero.
La violenza contro i civili, spesso usati come scudi umani, ha raggiunto livelli inauditi. Fa venire i brividi il ricordo dei pazienti, che sventolavano disperatamente, nel ’95, lenzuola bianche all’ospedale di Budionnovsk attaccato da un’unità al comando del guerrigliero Basaev. Il timore era che l’ex Armata rossa aprisse il fuoco con l’artiglieria pesante contro l’edificio. Al teatro moscovita della Dubrovka nel 2002 i più sfortunati tra gli spettatori-prigionieri sono morti affogati nel proprio vomito, dopo che i corpi speciali avevano usato un gas speciale per il blitz. Il massimo dell’infamia lo si è, però, vissuto a Beslan, dove un gruppo di delinquenti, armati fino ai denti, assaltò una scuola piena di bambini ed adolescenti. Le rovine della palestra bruciata, le bottiglie d’acqua – a testimoniare la terribile sete patita dagli allievi in quegli interminabili tre giorni – e le candele con la loro fiamma fioca rimangono un simbolo di vergogna inarrivabile. 334 innocenti morirono per niente.
Come non menzionare i tanti giornalisti, famosi e meno, che si sono immolati per raccontare al mondo quell’inferno. “Vado laggiù a vedere la situazione”, ci salutò Jochen Piest, 30enne corrispondente di Stern, in una gelida mattinata del gennaio ’95. Il suo sorriso, pieno di gioia, fu spento per l’eternità 4 giorni dopo da una raffica di kalashnikov. La bottiglia con le monetine radunate per comprare nei mesi successivi le scarpe per la sua sposa si è riempita di polvere sullo scaffale. Qualcun altro l’ha fatta franca in Cecenia, ma il destino è implacabile. E’ il caso di Valerij Batuev, reporter della Vremja MN, ucciso a Mosca nel suo appartamento da dei balordi. Accompagnava spesso i colleghi stranieri in Caucaso e la guerra gli era entrata talmente dentro che scriveva versi su di lei.
Come non dimenticare il poliziotto moscovita Misha, che era partito volontario per la Cecenia per sbarcare il lunario. I soldi che guadagnava non bastavano a sfamare la moglie e i due figlioli. Il piccolo gruzzolo racimolato gli è servito per andare dal dentista e farsi mettere i denti davanti mancanti.
“La prima sensazione è che in Cecenia non cambi mai nulla, neanche a morire – scriveva la grande reporter russa Anna Politkovskaja nel suo diario il 12 febbraio 2004 -. Tutti fanno la guerra a tutti. Gente armata ovunque. Si ha paura del prossimo. I visi hanno tutti la stessa espressione tetra. Tanti nevrotici, mezzi matti. La sintomatologia notturna: sparatorie, combattimenti, colpi d’artiglieria. Quella mattutina: crateri freschi provocati dalle esplosioni”.
Una follia collettiva ed un massacro orribile: ecco cosa è stato il conflitto ceceno. La scia di lutti è tipica degli scontri in Caucaso, terra-crocevia dove, per secoli, si sono incontrati imperi diversi. Turchi, persiani, russi e popolazioni locali se le sono sempre date di santa ragione. La differenza è che questa volta le tradizionali regole dell’onore sono completamente saltate. I giovani si sono schierati contro gli anziani; le donne hanno preso le armi nonostante l’opinione degli uomini. La secolare società cecena, divisa in clan, ha subito colpi durissimi portati dall’estremismo wahhabita importato dall’Arabia. Chi avrebbe mai immaginato di vedere delle ragazze kamikaze che volevano vendicare i propri mariti uccisi dall’esercito federale?
Un passo indietro serve a comprendere le cause di questa immane tragedia, figlia del crollo dell’Urss, quando per Mosca fu impossibile spiegare a Grozny che i kazakhi, i baltici o gli ucraini potevano diventare indipendenti, mentre loro, i ceceni, no. La Federazione russa avrebbe rischiato la disintegrazione dopo l’Unione Sovietica. Per il Cremlino, perdere il controllo del Caucaso avrebbe significato aprire la strada ad altri movimenti secessionisti e la diffusione di organizzazioni radicali nel “ventre molle” del Paese, sul Volga, dove vivono milioni di musulmani.
I ceceni, però, non vollero sentire ragioni. Nell’autunno ’91 si dichiararono indipendenti ed elessero come presidente un leggendario generale dell’aviazione sovietica, Giokar Dudaev. Mosca si rese conto della gravità della situazione, quando comprese che l’unico oleodotto, proveniente dal mar Caspio, era finito nelle mani dei separatisti. Dopo lunghe trattative scoppiò la guerra nel dicembre ’94. Fu una carneficina. Centinaia di migliaia furono i profughi.
Nell’agosto ’96 a Khasarviurt venne firmata la pace. La Cecenia diventò praticamente indipendente. Seguirono tre anni in cui la repubblica ribelle si trasformò in una specie di “terra di nessuno”. I vari clan ceceni si fecero la guerra fra loro. Vivevano di rapimenti, di contrabbando di petrolio e dei traffici più strani. Tutte le organizzazioni ed imprese internazionali vennero evacuate. Solo l’Afghanistan, l’Arabia Saudita e gli Emirati arabi riconobbero il governo ceceno. Grozny si trasformò presto in una delle basi del terrorismo islamico.
Poi nell’autunno ’99, a seguito di una lunga ondata di attentati, attribuiti ai ceceni, e della fallita invasione dei mujaheddin islamici del vicino Daghestan, Vladimir Putin – che al Cremlino stava per prendere il posto di Boris Eltsin – architettò la strategia giusta. La Russia rioccupò in tre mesi la repubblica ribelle, usando quell’acume che le era mancato durante la prima campagna. I capi del frammentato fronte separatista e i sempre più influenti mercenari “arabi” fuggirono sui monti. Iniziarono la guerriglia e gli attentati.
Putin ha vinto la partita perché riuscì a dividere i nemici: si appoggiò al clan più forte della Cecenia che prese, in breve, il sopravvento sugli altri. I comandanti avversari vennero sistematicamente eliminati con operazioni dei servizi segreti. Un conflitto internazionale, quasi incontrollabile, venne degradato a scontro puramente locale, dove Mosca impose la forza delle leggi e della sua Costituzione regionale.
Dopo l’uccisione di Akhmad Kadyrov nel maggio 2004 fu il figlio, Ramzan, a prendere le redini del clan-milizia e da quei giorni è diventato il vero “uomo forte” del Caucaso settentrionale russo. “La Cecenia di oggi – ha osservato di recente il nuovo presidente ceceno – è un’area pacifica in pieno sviluppo. Si incoraggia la crescita economica. I leader militanti, sulla cui coscienza pende il dolore e la sofferenza di migliaia di persone, sono stati eliminati, catturati o portati davanti ai giudici”.
Il centro di Grozny, la capitale cecena, che, fino a pochi anni fa, veniva paragonato ai ruderi di Stalingrado della Seconda guerra mondiale non porta più i segni spettrali del conflitto. Un’imponente moschea ed il corso principale dedicato a Vladimir Putin, pieno di negozi, testimoniano che il tempo delle armi è concluso da un pezzo. Il desiderio di indipendenza da Mosca di una parte della società cecena è ormai scemato. Sono poche decine i guerriglieri rimasti alla macchia sulle montagne.
Il Cremlino ne ha, quindi, preso atto in primavera, ma è dal 2004 che non si registrano veri attacchi armati. Sono state eliminate varie misure di sicurezza che vanno dal coprifuoco ai blocchi stradali ai rastrellamenti alla ricerca di estremisti islamici.
Si sono dischiuse indirettamente maggiori possibilità per gli investimenti e per dare un impiego stabile alla popolazione, circa 1,2 milioni di abitanti. Uno dei sogni nascosti dell’odierna leadership regionale è di collegare Grozny con voli aerei diretti provenienti dall’estero.
La nuova ondata di violenza nelle repubbliche confinanti è stata una vera doccia fredda. Non pochi terroristi hanno semplicemente passato la frontiera. Il presidente federale Medvedev ha incaricato Kadyrov di intensificare la lotta contro i “banditi”, che dalla sua repubblica hanno sconfinato nelle vicine Inguscezia e Daghestan. Nella prima, il 10 giugno scorso, sono stati uccisi la vice capo della Corte Suprema – mentre lasciava i bambini a scuola – e, tre giorni prima, un ex vice primo ministro. Lunedì 22 è stato ferito gravemente il presidente inguscio Junus-Bek Evkurov, per di più nello stesso luogo dove, cinque anni fa, era stata organizzata un’analoga azione contro l’allora presidente inguscio Murat Zjazikov. In Daghestan, ad inizio mese, è stato assassinato il ministro regionale degli Interni con fucili ad alta precisione in uso soltanto ad alcuni reparti delle forze speciali.
Lo speaker della Duma (la Camera bassa del Parlamento russo) Boris Gryzlov ha chiesto una dura risposta in Caucaso anche perché l’obiettivo dei “banditi” è di destabilizzare la situazione. Il senatore ceceno Aslambek Aslakhanov ritiene che Evkurov non andava più bene sia ai guerriglieri sia ad altri. Il presidente inguscio aveva dato pubblicamente il suo numero di cellulare ai cittadini per denunciare gli abusi dei funzionari, gli stipendi in ritardo e l’inestricabile rete di legami tra strutture deviate dello Stato e terroristi. Insomma il solito pantano caucasico. Altri esponenti politici spingono per migliori politiche sociali e maggiori investimenti del Centro nella Russia meridionale. Un elemento è però innegabile: a troppe persone conviene che la guerra in Caucaso continui. Se venisse a mancare il pericolo islamico perché Mosca dovrebbe spendere i suoi pochi petro-rubli rimasti nel bilancio proprio in queste terre dimenticate?
Il campanello d’allarme al Cremlino suona, comunque, da settimane. Il 22 giugno 2004 l’Inguscezia, che in epoca sovietica costituiva insieme alla Cecenia un unico soggetto della Russia, venne messa a ferro e fuoco per una notte da guerriglieri radicali. L’azione fu il prologo dell’attacco traditore alla scuola di Beslan. La speranza è che certi ricorsi storici non si ripetano più.
Giuseppe D’Amato
Russia – Usa, “reset” – Aprile 2009
25 Aug 2009A Londra Medvedev ed Obama hanno voltato “pagina”. La politica del “reset” nelle relazioni bilaterali ha preso il sopravvento sulle diatribe delle passate Amministrazioni Putin – Bush. Si supera il clima teso creatosi con lo scoppio della guerra in Ossezia meridionale nell’agosto scorso. Il mondo tira un sospiro di sollievo anche perché il corso legale di una delle fondamenta della sicurezza internazionale, il trattato Start-1, è in scadenza il 5 dicembre prossimo. Serve un accordo a tutti i costi, altrimenti sarebbero imprevedibili le conseguenze.
La gravissima crisi economica – a livello mondiale, negli Stati Uniti ed in Russia – impone di evitare un’improbabile nuova corsa agli armamenti. Gli ultimi dati rendono soprattutto Mosca meno baldanzosa. Il governo Putin prevede una riduzione nel 2009 del Pil al + 2% dall’oltre +6% del 2008; la Banca mondiale parla, invece, di -4,5% e l’Ocse addirittura -5,6%.
Obama ha rimarcato che le “divergenze” con il Cremlino in alcuni campi restano, ma con Medvedev si rincontrerà presto in Russia. Entro luglio, infatti, i negoziatori dovranno consegnare i primi risultati della complessa trattativa per il rinnovo dello Start. Mosca richiede a gran voce al suo interno anche norme che proibiscano agli Usa di installare il loro Scudo spaziale in Europa centrale. E’ bene dirlo subito: non sarà facile quadrare il cerchio, ma la necessità spingerà le parti ad inventarsi qualcosa per raggiungere l’obiettivo.
Obama deve assolutamente recuperare il rapporto con la Russia se ha in cuor suo di fare progressi in altri scenari. Il neopresidente statunitense è conscio che le chiavi del programma nucleare di Teheran sono a Mosca, che intrattiene buoni rapporti anche con Siria, Iran, Hamas ed Hezbollah. Instaurare relazioni franche con Dmitrij Medvedev significa indirettamente fare progressi rilevanti in Medio Oriente.
E poi la Nato, senza l’aiuto logistico della Russia, fa fatica in Afghanistan. Il nodo centrale è l’approvvigionamento delle truppe alleate. Sia il Cremlino che la Casa bianca hanno fini comuni a Kabul, ma le liti li hanno messi in secondo piano nonostante il grave pericolo rappresentato dall’estremismo islamico.
Nelle ultime settimane i contatti informali tra le due Amministrazioni sono stati febbrili. Obama ha inviato a Mosca l’ex segretario di Stato Henry Kissinger con suoi messaggi personali. Si devono ricostruire legami di fiducia e comprensione.
L’“unilateralismo” americano alla Bush è finito. Scudo spaziale ed allargamento della Nato ad Est nello spazio ex sovietico potranno avvenire più in là – non nei prossimi due-tre anni -, coinvolgendo il gigante slavo in questo processo. Attenzione, però, alla grana in avvicinamento per il controllo dell’Artico, un quarto del quale è rivendicato da Mosca.
Primavera 2009
Eurovision 2009. Scontro epocale
25 Aug 2009Gli occidentali hanno il calcio con la Champions League. Gli ex sovietici la musica con il festival della canzone continentale Eurovision. In palio vi è sempre l’onore nazionale. Mai nei 53 anni precedenti della competizione si erano registrati tanti scandali. Ma c’era da aspettarselo. Nel maggio 2008 a Belgrado vinsero i russi, che hanno acquisito il diritto di organizzare a Mosca la gara dell’anno successivo. Due i momenti principali di scontro: la canzone in rappresentanza della Georgia, Paese che ha combattuto in estate una sanguinosa guerra contro il Cremlino, e la selezione di quella padrona di casa.
A Tbilisi ha trionfato il motivetto in inglese “We don’t wanna put in”, che, per assonanza, quando viene eseguito il ritornello, sembra diventare “We don’t want Putin” (noi non vogliamo Putin). Il gruppo Stephane and 3G non si accontenta solo di cantare qualcosa di poco accettabile per il potere moscovita, ma si spinge oltre mimando persino il gesto di puntare una pistola e sparare. Immaginabile la reazione dei russi, che hanno preso serissimamente la competizione organizzata con il patrocinio del governo. “Siamo dispiaciuti – ha detto il portavoce di Putin, Dmitrij Peshkov, – che i georgiani usino una gara così popolare in Europa per dimostrare le loro ambizioni semipolitiche”.
Dietro alle quinte i russi hanno lavorato sodo e sono riusciti a far escludere dalla giuria internazionale questa canzone. Tbilisi ha così deciso di non inviare alcun rappresentante, adducendo rischi alla sicurezza personale. “We don’t wanna put in” è orecchiabile ed aveva concrete possibilità di sbancare Eurovision. Quasi tutti i Paesi dell’ex blocco sovietico, oggi in aperto contrasto con Mosca, l’avrebbero votata. Uno smacco del genere in casa sarebbe stato difficilmente digeribile dai russi!
Il festival europeo verrà guardato dall’intero gigante slavo disteso su 11 fusi orari. Ecco perché era importante la selezione di chi avrebbe difeso l’onore nazionale all’Olimpiskij stadion. Ha vinto la 21enne Anastasia Prikhodko con “Mamo”, ossia “mamma”. Gran parte delle strofe è in russo, mentre il ritornello è in ucraino. La ragazza è di Kiev con tanto di passaporto della repubblica slava sorella, entrata in contrasto con il Cremlino per il gas. Il testo di “Mamo” è stato scritto da un noto compositore georgiano, Konstantin Meladze. Di nuovo i georgiani! I georgiani, del resto, nel panorama canterino ex sovietico, sono come i napoletani in Italia.
Disgrazia, vergogna, shock sono i commenti più gettonati tra i pretendenti sconfitti e sulla stampa. “Cosa cavolo c’entri un’ucraina con la Russia”, è la domanda più comune nei forum di Internet, nonostante Anastasia Prikhodko non sia una sconosciuta ed abbia vinto la settima edizione di “Fabbrica delle stelle”.
La sua canzone non era stata selezionata per Eurovision dagli ucraini, che non volevano essere rappresentati da una canzone con alcune strofe in russo. Nel 2007 Kiev aveva scelto Verka Serdjuchka. La sua “Lasha Tumbai”, quando veniva eseguita, sembrava trasformare il ritornello ufficiale in “Russia goodbye” (Russia, arrivederci). Insomma dall’ascia di guerra alla guerra dei microfoni. L’evoluzione sembra positiva.
Marzo – Aprile 2009
Dovevano essere i nuovi Carnegies e Rockfellers in salsa russa. Ed invece la crisi economica li sta facendo definitivamente tramontare. Gli oligarchi dell’ex superpotenza sono in gravissima difficoltà. Le conferme giungono dalle riviste specializzate, ad iniziare dall’americana Forbes. A Mosca ora vivono solo 27 Paperoni. Chi aveva investito nel settore immobiliare ha subito perdite pesantissime quasi come chi controlla le società minerarie.
L’autorevole Finans ha calcolato che, in 12 mesi, il numero dei magnati russi tra i miliardari del mondo si è più che dimezzato, da 101 a 49. I primi dieci hanno lasciato sul terreno insieme 75,9 miliardi di dollari. In totale il costo della crisi per i tycoon federali si aggira ben oltre i 300 miliardi.
L’assottigliamento del portafoglio va di pari passo con la perdita di peso politico. Gli oligarchi non sono più l’ago della bilancia in Russia. I fili del gioco sono tornati saldamente nelle mani del Cremlino, che ha piazzato i suoi uomini nei consigli d’amministrazione delle principali aziende.
La crisi finanziaria ha completato, quindi, il successo del piano di Vladimir Putin di riportare l’economia sotto il pieno controllo della politica. Nessun oligarca, in questo momento, si sognerebbe mai di sfidare il potere come fece, all’inizio del Duemila, Michail Khodorkovskij, poi finito a soggiornare nelle patrie galere. Oggi è il Cremlino a decidere chi tra i magnati salverà il suo gruzzolo o verrà fatto fallire o sarà obbligato a cedere le proprie società.
Il 41enne Oleg Deripaska era all’inizio del 2008 l’oligarca più ricco di Russia. Sembrava che la sua fortuna non dovesse finire mai. Si parlava di 40 miliardi di dollari. Ed invece, nell’arco di quattro mesi, il crollo della Norilsk Nickel ed il ridimensionamento della RusAl ha trascinato anche lui. Gli incontri nelle stanze del potere si susseguono di continuo per trovare il modo di salvare il salvabile.
Lo stesso Michail Prokhorov, che nell’aprile 2008 vendette a Deripaska il 25% della Norilsk Nickel intascando 7 miliardi in contanti, è stato costretto a chiedere di ridiscutere il prezzo (496 milioni di euro concordato in precedenza) per l’acquisto di una famosa villa, già della famiglia Agnelli, in Costa azzurra. E lui è oggi l’uomo più ricco di Russia con un patrimonio di 14,1 miliardi di dollari.
Segue Roman Abramovich con 13,9. Il “patron” del Chelsea ha deciso di rimandare persino il suo terzo matrimonio con l’affascinante modella Dasha. Non è il momento per certi sfarzosi festeggiamenti, avrebbe detto alla futura sposa. In pochi mesi l’ex governatore della gelida Ciukotka ha bruciato, secondo alcune stime, circa 14 miliardi di euro. Voci sulla possibile vendita del suo gioiello calcistico ne girano da mesi. Chissà, messe in giro dal solito annoiato emiro arabo di turno in cerca di pubblicità e di occasioni per spendere i petrodollari.
L’oligarca più in disgrazia resta, comunque, Michail Khodorkovskij, che non comprese che l’epoca Eltsin era finita in Russia con l’avvento al potere di Vladimir Putin. Il suo guanto di sfida venne preso come un affronto. Sembrava la riedizione moderna della lite tra Ivan il terribile ed il principe Kurbskij. Con la differenza, questa volta, che lo sfidante – invece di prendere la via dell’esilio – se ne rimase tranquillo in Patria a dirigere il suo impero petrolifero.
La conclusione la conoscono tutti: la sua società, la Yukos, è stata smembrata e l’ex magnate è ospite delle prigioni siberiane dal 2004. Se il nuovo procedimento giudiziario, di recente apertosi, per operazioni finanziarie illecite e riciclaggio gli andrà male Khodorkovskij rischia di passare il resto della sua esistenza dietro alle sbarre. A nulla sono valsi finora gli appelli dei tanti suoi amici sparsi nelle cancellerie occidentali. Colpire uno per educare gli altri, è stata la strategia vincente adottata dal Cremlino. Nessun altro Paperone si è più permesso di scontrarsi con il potere politico che ora torna padrone della Russia.
Primavera 2009
Welcome
We are a group of long experienced European journalists and intellectuals interested in international politics and culture. We would like to exchange our opinion on new Europe and Russia.
Categories
- Breaking News (11)
- CIS (129)
- Climate (2)
- Energy&Economy (115)
- EU Eastern Dimension (85)
- Euro 2012 – Sochi 2014 – World Cup 2018, Sport (43)
- Euro-Integration (135)
- History Culture (198)
- International Policy (261)
- Military (74)
- Interviews (18)
- Italy – Italia – Suisse (47)
- Odd Enough (10)
- Poland and Baltic States (126)
- Religion (31)
- Russia (421)
- Survey (4)
- Turning points (4)
- Ukraine (176)
- Российские страницы (113)
Archives
- November 2020
- October 2020
- September 2020
- August 2020
- July 2020
- May 2020
- April 2020
- March 2020
- January 2020
- December 2019
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- July 2019
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- May 2017
- March 2017
- January 2017
- December 2016
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- July 2016
- June 2016
- May 2016
- April 2016
- February 2016
- January 2016
- November 2015
- October 2015
- September 2015
- June 2015
- April 2015
- March 2015
- February 2015
- January 2015
- December 2014
- November 2014
- October 2014
- September 2014
- August 2014
- July 2014
- June 2014
- May 2014
- April 2014
- March 2014
- February 2014
- January 2014
- December 2013
- November 2013
- October 2013
- September 2013
- August 2013
- July 2013
- June 2013
- May 2013
- April 2013
- March 2013
- February 2013
- January 2013
- December 2012
- November 2012
- October 2012
- September 2012
- August 2012
- July 2012
- June 2012
- May 2012
- April 2012
- March 2012
- February 2012
- January 2012
- December 2011
- November 2011
- October 2011
- September 2011
- August 2011
- July 2011
- June 2011
- May 2011
- April 2011
- March 2011
- February 2011
- January 2011
- December 2010
- November 2010
- October 2010
- September 2010
- August 2010
- July 2010
- June 2010
- May 2010
- April 2010
- March 2010
- February 2010
- January 2010
- December 2009
- November 2009
- October 2009
- September 2009
- August 2009
Our books