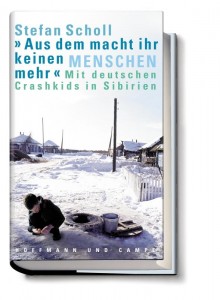All Italiano posts
Cecenia: vince la “pax russa” – primavera 2009
25 Aug 2009Doveva essere una guerra-lampo, genitrice di gloria per tutti, contro dei selvaggi male armati. Ed invece fu il disastro. Dopo 7 decenni di “pax sovietica” il Caucaso è tornato ad essere una delle zone più instabili e pericolose del pianeta. E come sempre accade in queste tragedie è l’umanità ad avere perso.
Sono tante le immagini che si affollano nella mente del cronista ora che ufficialmente, dal 16 aprile 2009, la guerra in Cecenia è finita. Indimenticabili sono gli occhi fieri di Akhmad Kadyrov, l’ex muftì che, ad inizio decennio, abbandonò con coraggio le file dei separatisti per diventare il centro delle strategie vincenti del Cremlino. Semplicemente gigantesca era la sua guardia del corpo, famose per il basso tasso di sopravvivenza con quel incarico. Lo sguardo triste delle adolescenti kamikaze, vestite di nero con ai fianchi le cinture piene di dinamite, ha colmato di orrore il mondo intero.
La violenza contro i civili, spesso usati come scudi umani, ha raggiunto livelli inauditi. Fa venire i brividi il ricordo dei pazienti, che sventolavano disperatamente, nel ’95, lenzuola bianche all’ospedale di Budionnovsk attaccato da un’unità al comando del guerrigliero Basaev. Il timore era che l’ex Armata rossa aprisse il fuoco con l’artiglieria pesante contro l’edificio. Al teatro moscovita della Dubrovka nel 2002 i più sfortunati tra gli spettatori-prigionieri sono morti affogati nel proprio vomito, dopo che i corpi speciali avevano usato un gas speciale per il blitz. Il massimo dell’infamia lo si è, però, vissuto a Beslan, dove un gruppo di delinquenti, armati fino ai denti, assaltò una scuola piena di bambini ed adolescenti. Le rovine della palestra bruciata, le bottiglie d’acqua – a testimoniare la terribile sete patita dagli allievi in quegli interminabili tre giorni – e le candele con la loro fiamma fioca rimangono un simbolo di vergogna inarrivabile. 334 innocenti morirono per niente.
Come non menzionare i tanti giornalisti, famosi e meno, che si sono immolati per raccontare al mondo quell’inferno. “Vado laggiù a vedere la situazione”, ci salutò Jochen Piest, 30enne corrispondente di Stern, in una gelida mattinata del gennaio ’95. Il suo sorriso, pieno di gioia, fu spento per l’eternità 4 giorni dopo da una raffica di kalashnikov. La bottiglia con le monetine radunate per comprare nei mesi successivi le scarpe per la sua sposa si è riempita di polvere sullo scaffale. Qualcun altro l’ha fatta franca in Cecenia, ma il destino è implacabile. E’ il caso di Valerij Batuev, reporter della Vremja MN, ucciso a Mosca nel suo appartamento da dei balordi. Accompagnava spesso i colleghi stranieri in Caucaso e la guerra gli era entrata talmente dentro che scriveva versi su di lei.
Come non dimenticare il poliziotto moscovita Misha, che era partito volontario per la Cecenia per sbarcare il lunario. I soldi che guadagnava non bastavano a sfamare la moglie e i due figlioli. Il piccolo gruzzolo racimolato gli è servito per andare dal dentista e farsi mettere i denti davanti mancanti.
“La prima sensazione è che in Cecenia non cambi mai nulla, neanche a morire – scriveva la grande reporter russa Anna Politkovskaja nel suo diario il 12 febbraio 2004 -. Tutti fanno la guerra a tutti. Gente armata ovunque. Si ha paura del prossimo. I visi hanno tutti la stessa espressione tetra. Tanti nevrotici, mezzi matti. La sintomatologia notturna: sparatorie, combattimenti, colpi d’artiglieria. Quella mattutina: crateri freschi provocati dalle esplosioni”.
Una follia collettiva ed un massacro orribile: ecco cosa è stato il conflitto ceceno. La scia di lutti è tipica degli scontri in Caucaso, terra-crocevia dove, per secoli, si sono incontrati imperi diversi. Turchi, persiani, russi e popolazioni locali se le sono sempre date di santa ragione. La differenza è che questa volta le tradizionali regole dell’onore sono completamente saltate. I giovani si sono schierati contro gli anziani; le donne hanno preso le armi nonostante l’opinione degli uomini. La secolare società cecena, divisa in clan, ha subito colpi durissimi portati dall’estremismo wahhabita importato dall’Arabia. Chi avrebbe mai immaginato di vedere delle ragazze kamikaze che volevano vendicare i propri mariti uccisi dall’esercito federale?
Un passo indietro serve a comprendere le cause di questa immane tragedia, figlia del crollo dell’Urss, quando per Mosca fu impossibile spiegare a Grozny che i kazakhi, i baltici o gli ucraini potevano diventare indipendenti, mentre loro, i ceceni, no. La Federazione russa avrebbe rischiato la disintegrazione dopo l’Unione Sovietica. Per il Cremlino, perdere il controllo del Caucaso avrebbe significato aprire la strada ad altri movimenti secessionisti e la diffusione di organizzazioni radicali nel “ventre molle” del Paese, sul Volga, dove vivono milioni di musulmani.
I ceceni, però, non vollero sentire ragioni. Nell’autunno ’91 si dichiararono indipendenti ed elessero come presidente un leggendario generale dell’aviazione sovietica, Giokar Dudaev. Mosca si rese conto della gravità della situazione, quando comprese che l’unico oleodotto, proveniente dal mar Caspio, era finito nelle mani dei separatisti. Dopo lunghe trattative scoppiò la guerra nel dicembre ’94. Fu una carneficina. Centinaia di migliaia furono i profughi.
Nell’agosto ’96 a Khasarviurt venne firmata la pace. La Cecenia diventò praticamente indipendente. Seguirono tre anni in cui la repubblica ribelle si trasformò in una specie di “terra di nessuno”. I vari clan ceceni si fecero la guerra fra loro. Vivevano di rapimenti, di contrabbando di petrolio e dei traffici più strani. Tutte le organizzazioni ed imprese internazionali vennero evacuate. Solo l’Afghanistan, l’Arabia Saudita e gli Emirati arabi riconobbero il governo ceceno. Grozny si trasformò presto in una delle basi del terrorismo islamico.
Poi nell’autunno ’99, a seguito di una lunga ondata di attentati, attribuiti ai ceceni, e della fallita invasione dei mujaheddin islamici del vicino Daghestan, Vladimir Putin – che al Cremlino stava per prendere il posto di Boris Eltsin – architettò la strategia giusta. La Russia rioccupò in tre mesi la repubblica ribelle, usando quell’acume che le era mancato durante la prima campagna. I capi del frammentato fronte separatista e i sempre più influenti mercenari “arabi” fuggirono sui monti. Iniziarono la guerriglia e gli attentati.
Putin ha vinto la partita perché riuscì a dividere i nemici: si appoggiò al clan più forte della Cecenia che prese, in breve, il sopravvento sugli altri. I comandanti avversari vennero sistematicamente eliminati con operazioni dei servizi segreti. Un conflitto internazionale, quasi incontrollabile, venne degradato a scontro puramente locale, dove Mosca impose la forza delle leggi e della sua Costituzione regionale.
Dopo l’uccisione di Akhmad Kadyrov nel maggio 2004 fu il figlio, Ramzan, a prendere le redini del clan-milizia e da quei giorni è diventato il vero “uomo forte” del Caucaso settentrionale russo. “La Cecenia di oggi – ha osservato di recente il nuovo presidente ceceno – è un’area pacifica in pieno sviluppo. Si incoraggia la crescita economica. I leader militanti, sulla cui coscienza pende il dolore e la sofferenza di migliaia di persone, sono stati eliminati, catturati o portati davanti ai giudici”.
Il centro di Grozny, la capitale cecena, che, fino a pochi anni fa, veniva paragonato ai ruderi di Stalingrado della Seconda guerra mondiale non porta più i segni spettrali del conflitto. Un’imponente moschea ed il corso principale dedicato a Vladimir Putin, pieno di negozi, testimoniano che il tempo delle armi è concluso da un pezzo. Il desiderio di indipendenza da Mosca di una parte della società cecena è ormai scemato. Sono poche decine i guerriglieri rimasti alla macchia sulle montagne.
Il Cremlino ne ha, quindi, preso atto in primavera, ma è dal 2004 che non si registrano veri attacchi armati. Sono state eliminate varie misure di sicurezza che vanno dal coprifuoco ai blocchi stradali ai rastrellamenti alla ricerca di estremisti islamici.
Si sono dischiuse indirettamente maggiori possibilità per gli investimenti e per dare un impiego stabile alla popolazione, circa 1,2 milioni di abitanti. Uno dei sogni nascosti dell’odierna leadership regionale è di collegare Grozny con voli aerei diretti provenienti dall’estero.
La nuova ondata di violenza nelle repubbliche confinanti è stata una vera doccia fredda. Non pochi terroristi hanno semplicemente passato la frontiera. Il presidente federale Medvedev ha incaricato Kadyrov di intensificare la lotta contro i “banditi”, che dalla sua repubblica hanno sconfinato nelle vicine Inguscezia e Daghestan. Nella prima, il 10 giugno scorso, sono stati uccisi la vice capo della Corte Suprema – mentre lasciava i bambini a scuola – e, tre giorni prima, un ex vice primo ministro. Lunedì 22 è stato ferito gravemente il presidente inguscio Junus-Bek Evkurov, per di più nello stesso luogo dove, cinque anni fa, era stata organizzata un’analoga azione contro l’allora presidente inguscio Murat Zjazikov. In Daghestan, ad inizio mese, è stato assassinato il ministro regionale degli Interni con fucili ad alta precisione in uso soltanto ad alcuni reparti delle forze speciali.
Lo speaker della Duma (la Camera bassa del Parlamento russo) Boris Gryzlov ha chiesto una dura risposta in Caucaso anche perché l’obiettivo dei “banditi” è di destabilizzare la situazione. Il senatore ceceno Aslambek Aslakhanov ritiene che Evkurov non andava più bene sia ai guerriglieri sia ad altri. Il presidente inguscio aveva dato pubblicamente il suo numero di cellulare ai cittadini per denunciare gli abusi dei funzionari, gli stipendi in ritardo e l’inestricabile rete di legami tra strutture deviate dello Stato e terroristi. Insomma il solito pantano caucasico. Altri esponenti politici spingono per migliori politiche sociali e maggiori investimenti del Centro nella Russia meridionale. Un elemento è però innegabile: a troppe persone conviene che la guerra in Caucaso continui. Se venisse a mancare il pericolo islamico perché Mosca dovrebbe spendere i suoi pochi petro-rubli rimasti nel bilancio proprio in queste terre dimenticate?
Il campanello d’allarme al Cremlino suona, comunque, da settimane. Il 22 giugno 2004 l’Inguscezia, che in epoca sovietica costituiva insieme alla Cecenia un unico soggetto della Russia, venne messa a ferro e fuoco per una notte da guerriglieri radicali. L’azione fu il prologo dell’attacco traditore alla scuola di Beslan. La speranza è che certi ricorsi storici non si ripetano più.
Giuseppe D’Amato
Russia – Usa, “reset” – Aprile 2009
25 Aug 2009A Londra Medvedev ed Obama hanno voltato “pagina”. La politica del “reset” nelle relazioni bilaterali ha preso il sopravvento sulle diatribe delle passate Amministrazioni Putin – Bush. Si supera il clima teso creatosi con lo scoppio della guerra in Ossezia meridionale nell’agosto scorso. Il mondo tira un sospiro di sollievo anche perché il corso legale di una delle fondamenta della sicurezza internazionale, il trattato Start-1, è in scadenza il 5 dicembre prossimo. Serve un accordo a tutti i costi, altrimenti sarebbero imprevedibili le conseguenze.
La gravissima crisi economica – a livello mondiale, negli Stati Uniti ed in Russia – impone di evitare un’improbabile nuova corsa agli armamenti. Gli ultimi dati rendono soprattutto Mosca meno baldanzosa. Il governo Putin prevede una riduzione nel 2009 del Pil al + 2% dall’oltre +6% del 2008; la Banca mondiale parla, invece, di -4,5% e l’Ocse addirittura -5,6%.
Obama ha rimarcato che le “divergenze” con il Cremlino in alcuni campi restano, ma con Medvedev si rincontrerà presto in Russia. Entro luglio, infatti, i negoziatori dovranno consegnare i primi risultati della complessa trattativa per il rinnovo dello Start. Mosca richiede a gran voce al suo interno anche norme che proibiscano agli Usa di installare il loro Scudo spaziale in Europa centrale. E’ bene dirlo subito: non sarà facile quadrare il cerchio, ma la necessità spingerà le parti ad inventarsi qualcosa per raggiungere l’obiettivo.
Obama deve assolutamente recuperare il rapporto con la Russia se ha in cuor suo di fare progressi in altri scenari. Il neopresidente statunitense è conscio che le chiavi del programma nucleare di Teheran sono a Mosca, che intrattiene buoni rapporti anche con Siria, Iran, Hamas ed Hezbollah. Instaurare relazioni franche con Dmitrij Medvedev significa indirettamente fare progressi rilevanti in Medio Oriente.
E poi la Nato, senza l’aiuto logistico della Russia, fa fatica in Afghanistan. Il nodo centrale è l’approvvigionamento delle truppe alleate. Sia il Cremlino che la Casa bianca hanno fini comuni a Kabul, ma le liti li hanno messi in secondo piano nonostante il grave pericolo rappresentato dall’estremismo islamico.
Nelle ultime settimane i contatti informali tra le due Amministrazioni sono stati febbrili. Obama ha inviato a Mosca l’ex segretario di Stato Henry Kissinger con suoi messaggi personali. Si devono ricostruire legami di fiducia e comprensione.
L’“unilateralismo” americano alla Bush è finito. Scudo spaziale ed allargamento della Nato ad Est nello spazio ex sovietico potranno avvenire più in là – non nei prossimi due-tre anni -, coinvolgendo il gigante slavo in questo processo. Attenzione, però, alla grana in avvicinamento per il controllo dell’Artico, un quarto del quale è rivendicato da Mosca.
Primavera 2009
Eurovision 2009. Scontro epocale
25 Aug 2009Gli occidentali hanno il calcio con la Champions League. Gli ex sovietici la musica con il festival della canzone continentale Eurovision. In palio vi è sempre l’onore nazionale. Mai nei 53 anni precedenti della competizione si erano registrati tanti scandali. Ma c’era da aspettarselo. Nel maggio 2008 a Belgrado vinsero i russi, che hanno acquisito il diritto di organizzare a Mosca la gara dell’anno successivo. Due i momenti principali di scontro: la canzone in rappresentanza della Georgia, Paese che ha combattuto in estate una sanguinosa guerra contro il Cremlino, e la selezione di quella padrona di casa.
A Tbilisi ha trionfato il motivetto in inglese “We don’t wanna put in”, che, per assonanza, quando viene eseguito il ritornello, sembra diventare “We don’t want Putin” (noi non vogliamo Putin). Il gruppo Stephane and 3G non si accontenta solo di cantare qualcosa di poco accettabile per il potere moscovita, ma si spinge oltre mimando persino il gesto di puntare una pistola e sparare. Immaginabile la reazione dei russi, che hanno preso serissimamente la competizione organizzata con il patrocinio del governo. “Siamo dispiaciuti – ha detto il portavoce di Putin, Dmitrij Peshkov, – che i georgiani usino una gara così popolare in Europa per dimostrare le loro ambizioni semipolitiche”.
Dietro alle quinte i russi hanno lavorato sodo e sono riusciti a far escludere dalla giuria internazionale questa canzone. Tbilisi ha così deciso di non inviare alcun rappresentante, adducendo rischi alla sicurezza personale. “We don’t wanna put in” è orecchiabile ed aveva concrete possibilità di sbancare Eurovision. Quasi tutti i Paesi dell’ex blocco sovietico, oggi in aperto contrasto con Mosca, l’avrebbero votata. Uno smacco del genere in casa sarebbe stato difficilmente digeribile dai russi!
Il festival europeo verrà guardato dall’intero gigante slavo disteso su 11 fusi orari. Ecco perché era importante la selezione di chi avrebbe difeso l’onore nazionale all’Olimpiskij stadion. Ha vinto la 21enne Anastasia Prikhodko con “Mamo”, ossia “mamma”. Gran parte delle strofe è in russo, mentre il ritornello è in ucraino. La ragazza è di Kiev con tanto di passaporto della repubblica slava sorella, entrata in contrasto con il Cremlino per il gas. Il testo di “Mamo” è stato scritto da un noto compositore georgiano, Konstantin Meladze. Di nuovo i georgiani! I georgiani, del resto, nel panorama canterino ex sovietico, sono come i napoletani in Italia.
Disgrazia, vergogna, shock sono i commenti più gettonati tra i pretendenti sconfitti e sulla stampa. “Cosa cavolo c’entri un’ucraina con la Russia”, è la domanda più comune nei forum di Internet, nonostante Anastasia Prikhodko non sia una sconosciuta ed abbia vinto la settima edizione di “Fabbrica delle stelle”.
La sua canzone non era stata selezionata per Eurovision dagli ucraini, che non volevano essere rappresentati da una canzone con alcune strofe in russo. Nel 2007 Kiev aveva scelto Verka Serdjuchka. La sua “Lasha Tumbai”, quando veniva eseguita, sembrava trasformare il ritornello ufficiale in “Russia goodbye” (Russia, arrivederci). Insomma dall’ascia di guerra alla guerra dei microfoni. L’evoluzione sembra positiva.
Marzo – Aprile 2009
Dovevano essere i nuovi Carnegies e Rockfellers in salsa russa. Ed invece la crisi economica li sta facendo definitivamente tramontare. Gli oligarchi dell’ex superpotenza sono in gravissima difficoltà. Le conferme giungono dalle riviste specializzate, ad iniziare dall’americana Forbes. A Mosca ora vivono solo 27 Paperoni. Chi aveva investito nel settore immobiliare ha subito perdite pesantissime quasi come chi controlla le società minerarie.
L’autorevole Finans ha calcolato che, in 12 mesi, il numero dei magnati russi tra i miliardari del mondo si è più che dimezzato, da 101 a 49. I primi dieci hanno lasciato sul terreno insieme 75,9 miliardi di dollari. In totale il costo della crisi per i tycoon federali si aggira ben oltre i 300 miliardi.
L’assottigliamento del portafoglio va di pari passo con la perdita di peso politico. Gli oligarchi non sono più l’ago della bilancia in Russia. I fili del gioco sono tornati saldamente nelle mani del Cremlino, che ha piazzato i suoi uomini nei consigli d’amministrazione delle principali aziende.
La crisi finanziaria ha completato, quindi, il successo del piano di Vladimir Putin di riportare l’economia sotto il pieno controllo della politica. Nessun oligarca, in questo momento, si sognerebbe mai di sfidare il potere come fece, all’inizio del Duemila, Michail Khodorkovskij, poi finito a soggiornare nelle patrie galere. Oggi è il Cremlino a decidere chi tra i magnati salverà il suo gruzzolo o verrà fatto fallire o sarà obbligato a cedere le proprie società.
Il 41enne Oleg Deripaska era all’inizio del 2008 l’oligarca più ricco di Russia. Sembrava che la sua fortuna non dovesse finire mai. Si parlava di 40 miliardi di dollari. Ed invece, nell’arco di quattro mesi, il crollo della Norilsk Nickel ed il ridimensionamento della RusAl ha trascinato anche lui. Gli incontri nelle stanze del potere si susseguono di continuo per trovare il modo di salvare il salvabile.
Lo stesso Michail Prokhorov, che nell’aprile 2008 vendette a Deripaska il 25% della Norilsk Nickel intascando 7 miliardi in contanti, è stato costretto a chiedere di ridiscutere il prezzo (496 milioni di euro concordato in precedenza) per l’acquisto di una famosa villa, già della famiglia Agnelli, in Costa azzurra. E lui è oggi l’uomo più ricco di Russia con un patrimonio di 14,1 miliardi di dollari.
Segue Roman Abramovich con 13,9. Il “patron” del Chelsea ha deciso di rimandare persino il suo terzo matrimonio con l’affascinante modella Dasha. Non è il momento per certi sfarzosi festeggiamenti, avrebbe detto alla futura sposa. In pochi mesi l’ex governatore della gelida Ciukotka ha bruciato, secondo alcune stime, circa 14 miliardi di euro. Voci sulla possibile vendita del suo gioiello calcistico ne girano da mesi. Chissà, messe in giro dal solito annoiato emiro arabo di turno in cerca di pubblicità e di occasioni per spendere i petrodollari.
L’oligarca più in disgrazia resta, comunque, Michail Khodorkovskij, che non comprese che l’epoca Eltsin era finita in Russia con l’avvento al potere di Vladimir Putin. Il suo guanto di sfida venne preso come un affronto. Sembrava la riedizione moderna della lite tra Ivan il terribile ed il principe Kurbskij. Con la differenza, questa volta, che lo sfidante – invece di prendere la via dell’esilio – se ne rimase tranquillo in Patria a dirigere il suo impero petrolifero.
La conclusione la conoscono tutti: la sua società, la Yukos, è stata smembrata e l’ex magnate è ospite delle prigioni siberiane dal 2004. Se il nuovo procedimento giudiziario, di recente apertosi, per operazioni finanziarie illecite e riciclaggio gli andrà male Khodorkovskij rischia di passare il resto della sua esistenza dietro alle sbarre. A nulla sono valsi finora gli appelli dei tanti suoi amici sparsi nelle cancellerie occidentali. Colpire uno per educare gli altri, è stata la strategia vincente adottata dal Cremlino. Nessun altro Paperone si è più permesso di scontrarsi con il potere politico che ora torna padrone della Russia.
Primavera 2009
“Questa è la più grave crisi dal tempo della grande Depressione americana”. Egor Gajdar, ex primo ministro nel ‘92-‘93 è il maggiore economista liberale del suo Paese. Una vera autorità. “Condivido – dice il padre della riforma dei prezzi nella Russia eltsiniana post sovietica – la previsione che il 2009 possa essere un anno molto pesante per l’economia internazionale”.
Secondo lei ci sarà una seria recessione per un paio di anni o addirittura qualcosa di più? Il professor Nouriel Roubini dell’Università di New York ritiene che non si può escludere una recessione sul tipo giapponese della durata di parecchi anni. “Non possono non essere d’accordo con lui anche perché il professor Roubini è uno specialista autorevole e bravo. Non si può escludere ora alcunché. Quanto questa crisi sia profonda e quanto essa possa durare sono due aspetti che sono difficili da prevedere. L’attuale crisi è completamente diversa da quelle passate dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Le crisi della seconda metà del XX secolo sono state principalmente delle reazioni dei poteri finanziari alla crescente inflazione. Quelle del XXI secolo sono state finora morbide e differente da quelle precedenti. Sono state una risposta al crack del Nasdaq e poi all’11 settembre con gli attentati terroristici a New York. La presente crisi è stata causata dai problemi dei mutui che si sono riversati successivamente sul sistema bancario”.
Parliamo adesso dell’Europa centrale ed orientale. Come si può descrivere la diversa situazione a seconda dei Paesi. Ucraina, Lettonia ed Ungheria sono una cosa, mentre in Polonia e Repubblica ceca è un’altra. “La crisi ha colpito anche l’ex spazio socialista ed in particolare l’Europa orientale come il resto del mondo. E’ più forte nei Paesi che avevano una bilancia dei pagamenti negativa. Chi ha invece radunato delle riserve valutarie più grandi, come la Russia, vive per ora una situazione migliore. Questo non significa, però, che sarà un compito facile”.
La Russia, quindi, vive una situazione migliore rispetto all’Ungheria ed all’Ucraina. “Sì. La Russia è in una posizione migliore di quella in Ungheria, Ucraina, Lettonia. Questo non significa che siamo in una situazione semplice. Come nemmeno l’Unione europea e gli Stati Uniti”.
Qualche settimana fa Lei ha dichiarato che se la Russia non compierà gravi errori potrà uscire da questa crisi senza troppi danni. A quali errori si riferiva? “Mi riferivo al rifiuto di rivedere seriamente la politica finanziaria considerando prospettive più reali in riferimento dal prezzo del petrolio. Alla necessità di un forte controllo della politica di spesa del bilancio; al rifiuto di una revisione della politica fiscale per l’abbassamento delle tasse; alle scelte per mantenere invariato il corso del rublo utilizzando le riserve valutarie. A giudicare dalle azioni intraprese il governo russo non vuole fare questi errori”.
Non le sembra che la difesa del rublo sia costata troppo: decine e decine di miliardi di dollari. Il corso della valuta russa è, comunque, pesantemente caduto. “Guardate il rapporto tra la massa monetaria e le riserve valutarie (ndr. le terze maggiori al mondo prima della crisi). E vedrete che le possibilità per controllare il corso del rublo sono più che sufficienti”.
Vuole dire, se abbiamo capito bene, che bisognava svalutare prima il rublo? “Preferisco non commentare questo tipo di affermazioni. Per ora la nostra politica monetaria ci permette di comportarci in modo tranquillo”.
Il cosiddetto ‘piano anti-crisi Putin’ ha 55 misure definite. Sono esse sufficienti? “Nessun piano è in grado di dare risposte a tutti i problemi. Bisognerebbe dare maggiore peso alle riforme istituzionali, al rafforzamento del diritto alla proprietà, alla garanzie di indipendenza del sistema giuridico. Tutto questo influenza l’atmosfera in Russia, la fuga dei capitali, gli investimenti privati”.
Alcune fonti parlano di un’imponente debito delle società private russe. 150-200 miliardi di dollari da saldare entro la fine del 2009. E se i grandi consorzi russi non potranno pagare. Cosa succederà? Lo Stato dovrà intervenire? “Toccherà loro vendere i loro attivi”.
Ma lo Stato non dovrebbe aiutare queste compagnie? “Lo Stato deve agire con estrema attenzione sugli aiuti alle compagnie, che hanno preso a prestito soldi. Lo Stato russo non li ha mai garantiti questi capitali. Queste compagnie possono utilizzare gli attivi che hanno e saldare i loro debiti”.
Il sistema bancario russo sopravviverà a questa crisi? “Sarà una prova dura. Le autorità finanziarie nazionali capiscono che le banche sono una priorità del sistema. Ritengo che alcuni istituti si troveranno in gravi difficoltà, ma in generale usciremo da questa crisi in una situazione migliore rispetto alla situazione in cui eravamo prima”.
Giuseppe D’Amato
Gennaio 2009
Nizza: Freddo vertice Ue-Russia – autunno 2008
25 Aug 2009Nizza. Il tiepido sole della Costa azzurra ha aiutato a scongelare i rapporti euro-russi. Il nuovo motto coniato sul Vara è “dialogo nel disaccordo e nelle differenze”. I due poli continentali hanno compreso che questo non è proprio il momento per continuare a litigare. Con il passaggio di potere alla presidenza negli Stati Uniti e con questa gravissima crisi finanziario – economica da affrontare il vento è davvero cambiato. Bruxelles e Mosca si riavvicinano. Primo: riprendono i negoziati per il rinnovo del Trattato strategico bilaterale decennale, scaduto un anno fa. Secondo: si accordano per evitare passi unilaterali in attesa – probabilmente a metà del 2009 – di una conferenza internazionale sulla sicurezza nel Vecchio continente, in America settentrionale ed in Russia. Terzo: concordano posizioni simili per il G-20 di oggi a Washington, proponendo la definizione di un’agenda precisa di impegni per giungere alla riforma delle istituzioni finanziarie mondiali. I partner statunitensi sono avvertiti: Unione europea e Russia spingono per ottenere posizioni migliori nei futuri organismi che gestiranno il globo nel XXI secolo e non si accontenteranno di semplici promesse.
A Nizza Nicolas Sarkozy, presidente di turno dell’Ue, si è sforzato di segnalare tutto ciò che unisce i due Poli continentali. “I negoziati per il Trattato decennale – ha sottolineato il capo dell’Eliseo – non sono stati congelati o fermati in estate, ma semplicemente rimandati”. Le diplomazie stanno lavorando per superare le incomprensioni sulla questione georgiana e per porre le basi per un vero confronto a Ginevra. La Russia, però, continua a riconoscere a metà l’integrità di Tbilisi, quindi senza Ossezia meridionale ed Abkhazia.
Inattesa è la svolta in materia di architettura militare e di sicurezza. Il presidente Medvedev ha girato il coltello nella piaga, rimarcando che gli Stati Uniti si sono accordati con Varsavia e Praga per dislocare il loro Scudo spaziale in Polonia e Repubblica ceca senza che questi due nuovi membri Ue avessero avvertito o concordato a loro volta questa scelta con i Ventisette. Bruxelles avrebbe semplicemente subito decisioni altrui. Adesso, però, con la nuova Amministrazione Obama le cose sono diverse e si può tornare indietro. E’ la fine dell’unilateralismo Usa e l’inizio di un’era multilaterale.
Il leader del Cremlino ha lasciato intendere che Mosca “reagirà”, ma non farà la prima mossa, ad esempio posizionare missili sul Baltico. Con il prezzo delle materie prime in caduta libera la Russia non può certo permettersi di tirare la corda.
Analoghe considerazioni giungono dalla Commissione europea. Nei giorni scorsi Barroso ha invitato i membri Ue ex satelliti del Cremlino filo-Usa a mutare atteggiamento, tentando di superare i loro storici problemi irrisolti con Mosca. Strategicamente, con il Medio oriente sempre in fermento e la Cina comunque un futuro punto interrogativo, l’Unione non può permettersi il lusso di non avere buoni rapporti con il Paese che le garantisce un quarto delle forniture energetiche.
Due ultime considerazioni. La drammatica situazione, creatasi in Caucaso in estate, ha dimostrato l’urgente necessità di una seria riforma politica dell’Ue. Senza le iniziative di mediazione di Sarkozy e le sue indubbie capacità un conflitto locale avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di molto più grave. Medvedev, invece, proseguirà nella sua linea di avvicinamento a vecchi e nuovi partner anti-occidentali.
Novembre 2008
Russia: un grattacielo rotante – 2008
25 Aug 2009Stanchi della solita vista, della luce troppo intensa in alcune ore della giornata e dei vicini che vi guardano dentro alle tapparelle? Presto i “nuovi ricchi” russi e del Dubai godranno di straordinarie contromisure e disporranno di un gioiello in più da esibire. Questa nuova settima meraviglia è il grattacielo rotante.
L’idea futuribile e la tecnologia sono completamente italiane. Come al solito, ciò che non riusciamo a realizzare a casa nostra immancabilmente viene apprezzato ed ha successo all’estero.
L’architetto fiorentino 58enne, David Fisher, è la “mente” del sorprendente progetto, presentato per l’ammirazione del pubblico a New York. Gran parte dei componenti verranno prefabbricati da un’azienda alle porte di Bari. Il primo edificio verrà costruito a Dubai entro il 2010 e sarà adibito ad hotel di super lusso, mentre il secondo nella capitale russa nel 2011-2012 dalla compagnia Mirax, che sta già erigendo la cosiddetta “Torre della Federazione”, uno dei simboli giganteschi della rinascita della Russia post sovietica.
Il grattacielo rotante di Mosca avrà una settantina di piani per 300 metri di altezza. Ogni piano potrà ruotare autonomamente, in senso orario o in senso anti-orario, per 360 gradi a seconda del desiderio del proprietario, avendo come fulcro un’immensa colonna centrale. Gli spostamenti avranno una velocità molto lenta da non risultare fastidiosi agli inquilini, che non percepiranno nemmeno il movimento od il rumore. Una completa rotazione durerà da una a tre ore.
Il grattacielo cambierà continuamente forma a seconda dei desideri di chi vi abita e produrrà elettricità in misura decisamente superiore al suo fabbisogno grazie allo sfruttamento dell’energia eolica e solare. Cellule fotovoltaiche verranno messe sul tetto di ogni piano rotante, 15% del quale sarà ad ogni ora esposto al sole, mentre verranno montate orizzontalmente tra un piano e l’altro delle turbine. In un anno la torre dovrebbe fornire circa 190 milioni di kilowatt di energia per un valore di oltre 7 milioni di euro.
I maggiori problemi tecnici sono stati quelli connessi con le tubature. La soluzione è stata trovata nell’uso di valvole simili a quelle utilizzate dagli aerei militari riforniti in volo. Oltre alle piscine ed ai giardini il grattacielo avrà speciali ascensori per auto così che i residenti potranno parcheggiare la loro vettura affianco dell’uscio del loro appartamento.
“La vita di oggi è dinamica – sostiene Fisher – così lo spazio in cui viviamo deve essere lo stesso dinamico. Gli edifici seguiranno i ritmi della natura, cambiando direzione e forma a seconda delle stagioni, della giornata, del tempo atmosferico”.
Architettura dinamica e sostenibilità dell’ambiente sono i due nuovi assi della genialità italiana, che in Russia gode di una stima ineguale. Se Rastrelli nel ‘700 fu uno di quelli a porre le fondamenta di San Pietroburgo Fisher ha ora la possibilità di entrare nella storia dell’ultramoderna Mosca.
Guerra Cibernetica – 2008
25 Aug 2009Pare che sia successo un’altra volta. Nell’ultimo week-end di giugno la Lituania ha subito un attacco cibernetico. La denuncia giunge da fonti ufficiali. I siti del governo, dei partiti politici, di società d’affari sono stati imbrattati con falci e martello e stelle a cinque punte e da slogan irridenti anti-lituani. Gli hacker hanno assaltato 300 siti, esattamente due settimane dopo che la repubblica baltica ha messo fuorilegge tutti i simboli sovietici.
Vilnius vive un periodo di tensione con Mosca. I deputati russi della Duma hanno invitato la Lituania a non accogliere sul proprio territorio elementi del cosiddetto “Scudo spaziale” Usa. Le trattative tra Polonia e Stati Uniti presentano delle difficoltà e Vilnius ha offerto in alternativa la sua disponibilità. Il primo ministro lituano Kirkilas è andato negli Stati Uniti per incontri con il segretario di Stato Condoleezza Rice.
Nessuno osa accusare apertamente Mosca, ma le coincidenze con un simile evento avvenuto nella primavera 2007 nella vicina Estonia sono sorprendenti. Allora si registrò un sofisticato attacco cibernetico dopo che il governo di Tallinn decise di spostare la statua di bronzo al Soldato sovietico dal centro della capitale in un cimitero di periferia. Durissimi furono gli scontri per strada, con un morto, in uno dei Paesi più avanzati tecnologicamente al mondo. I danni informatici non furono affatto secondari e minori rispetto ai negozi ed alle auto incendiati. Il Cremlino negò ogni addebito, asserendo che in passato persino il suo sito era stato attaccato da hacker baltici.
Gli specialisti della Nato hanno preso sul serio l’accaduto e l’hanno studiato nei minimi particolari. L’Estonia venne messa letteralmente in ginocchio da quantità mostruose di spam (ndr. “posta-spazzatura” non richiesta e pubblicità varia) e da altri strani marchingegni informatici, alcuni “rimbalzati” da oltreoceano. Per giornate intere non funzionò più niente: l’interazione tra la vita quotidiana estone, Intenet e i computer è una delle più alte in Europa. Dopo le accuse dei primi momenti contro la Russia Tallinn ha poi fatto marcia indietro. Gli specialisti stranieri, tra i quali anche quelli dell’Ue, non sono riusciti a trovare le necessarie risposte e le prove contro Mosca.
Secondo Linnar Viik, un guru estone informatico, solo uno Stato con la collaborazione di una compagnia telefonica può compiere certe azioni. Ciò che sorprende è che a livello internazionale non esiste una legislazione su questa materia. Il progresso avanza più velocemente delle leggi.
Gli esperti lituani temono che questo ultimo attacco cibernetico non sia altro che la punta di un iceberg. “I veri criminali – sostiene Gintautas Svedas, capo della SATi, specializzata in sicurezza – cercano sempre di rimanere coperti per usare segretamente i dati della vittima”. I computer potrebbero essere quindi pieni dei temibili “cavalli di Troia” ed essere così alla mercè degli hacker, che, in qualsiasi momento, potrebbero agire. Una bella vendetta dei nostalgici di Lenin.
Giuseppe D’Amato
Estate 2008
Guerre Stellari – 2008
25 Aug 2009 Dopo due decenni di stop sono nuovamente ricominciate le Guerre Stellari. Stati Uniti e Cina sono i maggiori contendenti, con la Russia osservatrice interessata, pronta ad entrare in gioco. Giovedì 21 febbraio 2008, alle 4,26 ora dell’Europa centrale, un missile lanciato dall’incrociatore Usa Lake Erie, in quel momento in navigazione nel Pacifico settentrionale ad ovest delle isole Hawaii, ha distrutto nello spazio un satellite spia militare in avaria. Era da 22 anni che Washington non eseguiva un tale tiro al bersaglio al di fuori dell’atmosfera. Ufficialmente il Pentagono ha giustificato questa scelta con il timore che l’Us-193, grande quanto un mini-bus e pesante 9 tonnellate, potesse provocare danni rientrando sulla Terra tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Il suo serbatoio conteneva l’idrazina, un combustibile altamente tossico. Da qui la decisione, presa dal presidente Bush in persona, dell’abbattimento.
Dopo due decenni di stop sono nuovamente ricominciate le Guerre Stellari. Stati Uniti e Cina sono i maggiori contendenti, con la Russia osservatrice interessata, pronta ad entrare in gioco. Giovedì 21 febbraio 2008, alle 4,26 ora dell’Europa centrale, un missile lanciato dall’incrociatore Usa Lake Erie, in quel momento in navigazione nel Pacifico settentrionale ad ovest delle isole Hawaii, ha distrutto nello spazio un satellite spia militare in avaria. Era da 22 anni che Washington non eseguiva un tale tiro al bersaglio al di fuori dell’atmosfera. Ufficialmente il Pentagono ha giustificato questa scelta con il timore che l’Us-193, grande quanto un mini-bus e pesante 9 tonnellate, potesse provocare danni rientrando sulla Terra tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Il suo serbatoio conteneva l’idrazina, un combustibile altamente tossico. Da qui la decisione, presa dal presidente Bush in persona, dell’abbattimento.
Russi e cinesi hanno dato una lettura diversa: questo degli americani era, in realtà, un test camuffato per provare il sistema di difesa anti-missile, il cosiddetto “Scudo spaziale”, che gli Stati Uniti stanno rapidamente sviluppando un po’ ovunque nel mondo. Nei prossimi anni tre siti saranno installati in Repubblica ceca ed in Polonia, mentre varie stazioni radar sono già state dislocate nel Pacifico vicino alle coste dell’Estremo oriente russo.
Il test è anche una risposta all’analogo lancio, operato dalla Cina l’11 gennaio 2007, quando – dopo tre precedenti falliti tentativi – un missile, partito da una base nel bel mezzo dell’Impero Celeste, colpì un satellite meteorologico a circa 865 chilometri d’altezza. Le proteste occidentali – oltre che la sorpresa dei militari – furono, allora, veementi. Nell’impatto si crearono più di 150mila frammenti fluttuanti attorno alla Terra. Secondo gli specialisti ben 2600 sono catalogati come “grossi”, ossia della grandezza di una decina di centimetri.
La mancanza di una tecnologia per ripulire lo spazio, dove sono già un paio di milioni le unità di spazzatura, ha fermato questo tipo di esperimenti dopo gli anni Ottanta, quando le due superpotenze ne realizzarono circa una cinquantina. Gravi sono i pericoli per la navigazione. Un piccolo frammento nell’orbita più bassa ha un impatto su un satellite, con più o meno la stessa energia, pari ad una tonnellata di un pezzo di marmo gettato da un edificio di 5 piani.
“Praticamente tutti i resti del satellite sono bruciati nell’atmosfera”, hanno rassicurato i militari a stelle e strisce, esaltando la loro “trasparenza”. L’Us-193 è stato colpito da un missile cinetico, senza carica esplosiva. Proiettile contro proiettile. Secondo alcuni esperti indipendenti, tuttavia, il 25% dei frammenti è destinato a restare nello spazio.
La Marina Usa ha utilizzato un SM-3 “Standard”, capace di centrare obiettivi a mille chilometri di distanza ed ad un’altezza di 200 chilometri. Per gli specialisti russi, questa volta, gli avversari della Guerra Fredda hanno usato una sua versione modificata per l’occasione con una gittata superiore. Questa è ad esempio l’opinione del colonnello Andrei Vlasikhin. L’impatto è avvenuto a 247 chilometri dalla Terra. I puntatori della Lake Erie hanno avuto solo 10 secondi per fissare l’obiettivo.
Il sistema Aegis con gli intercettori SM-3 è in dotazione ad un centinaio di navi di vari Paese, tra questi Usa, Giappone, Corea del Sud, Spagna, Gran Bretagna e Norvegia. Dieci unità dovrebbero essere posizionate presto in Polonia. L’SM-3 serve come difesa da attacchi aerei, missilistici e di vettori a piccolo raggio.
“Anche noi russi – commenta Vlasikhin – abbiamo intercettori di uguale potenza come i Gazel e i Galosha. Possono arrivare a 300 chilometri d’altezza. Poi ci sono i sistemi stellari S-300 e S-400. I cinesi hanno utilizzato nel gennaio 2007 un S-300, da noi acquistato e poi da loro modificato”.
I militari di Mosca hanno osservato con particolare attenzione l’Us-193. “E’ un satellite spia non comune – ha spiegato Igor Barinov, vice presidente del Comitato Difesa della Duma -. Là non ci sono batterie cosmiche. Non si può escludere qualche marchingegno nucleare a bordo”. Secondo alcuni calcoli, invero tutti da verificare, il velivolo impazzito sarebbe dovuto cadere tra la Polonia e la Bielorussia. Gli americani non avrebbero voluto che i rottami dell’Us-193 potessero finire in mani non amiche. La scusa dei veleni ha fatto sorridere: in continuazione cadono sulla Terra sostanze nocive e non si registrano catastrofi ecologiche. Il Pentagono ha mostrato i denti, scrivono i quotidiani moscoviti.
La realtà è che gli Stati Uniti sono il Paese al mondo a dipendere più di tutti dai suoi satelliti – per scopi militari, meteorologici, commerciali, di comunicazione, di navigazione – e ciò li rende particolarmente vulnerabili. Uno studio cinese, che ha analizzato la guerra in Irak nel 2003, ha stimato che “gli Usa sono dipesi dai satelliti per il 95% delle informazioni di riconoscimento e di sorveglianza, per il 90% delle comunicazioni militari, per il 100% della navigazione e posizionamento”.
Di conseguenza, sta iniziando una frenetica corsa alla difesa di questi mezzi volanti preziosissimi, sostiene Igor Lisov, direttore della rivista “Notizie della cosmografia”. La prima cosa che si può fare è l’applicazione ai satelliti della tecnologia Stealth, quella già in uso ai modernissimi caccia Usa, per evitare di essere localizzati. “Materiali non rintracciabili dai radar, velivoli colorati di nero”, sintetizza l’esperto britannico Stuart Eves. Il problema è che i pannelli solari per le batterie e gli infrarossi utilizzati sono difficili da nascondere. La soluzione è progettare satelliti di nuova generazione dalle dimensioni ridottissime. Insomma macchine volanti miniaturizzate e trionfo delle nano-tecnologie. Altra possibilità è avere a disposizione una grossa quantità di satelliti sostitutivi da lanciare subito in caso di distruzione del proprio gemello.
Secondo gli analisti il vantaggio militare di Washington su tutti i suoi concorrenti è ancora assai ampio. Ma come affermò lo stratega Andy Marshall, assai ascoltato dal segretario alla Difesa Donald Rumsfield agli inizi del Duemila, le tecnologie mettono in condizione i Paesi più deboli di creare problemi agli Usa. E’ necessario ammodernare l’arsenale, altrimenti gli Stati Uniti faranno la fine della Francia con la sua linea Maginot a cavallo tra le due guerre. “I cinesi – sottolinea Andrej Ionin della Roel Consulting – hanno sparato da una base fissa a terra, mentre gli americani da una nave che può trovarsi ovunque negli oceani”.
Che i satelliti e le comunicazioni ad uso civile siano obiettivi sensibili se ne accorsero anche i quasi sempre distratti europei. Con lo scoppio della guerra in Jugoslavia nel ’99 mezzo Vecchio Continente restò al buio. Gli americani spensero il loro Gps, ampiamente usato fino ad allora anche dai loro alleati per la navigazione. Da quei giorni l’Ue porta avanti tra tante difficoltà la realizzazione del progetto Galileo, mentre i russi il Glonass. Controllare questi sistemi significa mettere in ginocchio un intero Paese.
Russi e cinesi sono consci che esiste un buco spaventoso negli accordi internazionali sulla sicurezza. Il Trattato sullo spazio extra-atmosferico (Outer space Treaty), firmato da Usa, Urss e Regno Unito ed entrato in vigore il 10 ottobre 1967, parla di divieto di posizionare in orbita armi nucleari e di distruzione di massa. Ma non si fa menzione di normali armi, ad esempio missili a medio e corto raggio. Così, ad inizio di febbraio a Ginevra alla Conferenza sul disarmo, Mosca e Pechino hanno proposto un patto che vada oltre il Trattato del ’67. “No alla militarizzazione dello spazio”, è lo slogan scelto per questa battaglia. Il ministro degli Esteri russo Serghej Lavrov vorrebbe allargare il già esistente Trattato Start.
Gli Stati Uniti hanno un punto di vista diverso. “Siamo per una uguale accesso allo spazio per scopi pacifici – ha dichiarato il portavoce della Casa bianca Scott Stanzel -. Ma contrari alla creazione di regimi legali o di altri accordi internazionali che cercano di limitare o proibire il nostro utilizzo dello spazio”. In sostanza, Washington vuole avere la mani libere e non ridurre le sue opzioni militari. Vi è anche il problema non secondario che un qualsiasi accordo in tale campo è assai difficile da monitorare. Una delle questioni da superare, dicono gli esperti, è anche la definizione di arma: i laser, ad esempio, sono un’arma?
Dal 2001 l’Amministrazione Bush ha investito sempre maggiori fondi per i programmi spaziali. Nel 2008 il presidente Usa ha chiesto al Congresso un aumento delle spese del 25%, passando da 4,8 miliardi di dollari nel 2007 a 6 miliardi. Si sta creando un disequilibrio che rischia di influenzare l’intero sistema strategico internazionale.
I militari statunitensi guardano con preoccupazione non tanto alla Russia – il cui arsenale sta invecchiando rapidamente senza essere degnamente sostituito – quanto alla Cina. Nel ’57, quando Mosca mise in orbita il suo primo velivolo, Mao Zedong si lamentò che Pechino “non era in grado di mandare nello spazio nemmeno una patata”. Da allora le cose sono cambiate: nel 1970 la Cina lanciò il suo primo satellite, nel 2003 il primo astronauta e nel 2007 il primo test ASAT. “Ha un livello maggiore di capacità di quanto precedentemente pensassimo”, si è lasciato sfuggire Michael Staine, un esperto di questioni orientali dell’Istituto Carnegie. Un tempo i progressi militari dell’Impero celeste erano legati alla filosofia di “smorzare i toni e tenere un profilo basso”. Adesso, a giudicare dai fatti, non è più così, malgrado le dichiarazioni ufficiali affermino il contrario.
La ferita di Taiwan continua a sanguinare. Pechino vuole indietro la provincia ribelle e se serve la forza la userà. La settimana scorsa fonti ai agenzia russa hanno raccontato di un incontro segreto tra alti ufficiali americani e cinesi per mantenere la pace. E’ recente lo sgarbo del rifiuto di concedere l’attracco a tre navi da guerra Usa. Il misterioso furto di materiale “classificato” sul missile nucleare Trident dai laboratori di Los Alamos nel ’99 mise la Cina nel mirino di Washington. Se non vi fosse stato l’11 settembre era l’Impero Celeste a rappresentare la massima urgenza in politica estera per l’amministrazione Bush, che, prima di riconsegnare il mandato, consegna all’industria militare nazionale – uno dei suoi “Grandi elettori” – copiosi fondi.
A torto o a ragione è davvero non facile dare un giudizio. Il progresso tecnologico sta mettendo in crisi tutti i trattati in materia di armamenti.
Giuseppe D’Amato
Primavera 2008
Russia: Addio a Solgenitsin – agosto 2008
25 Aug 2009L’uomo del dissenso, il nemico “numero uno” del potere comunista in Patria e poi lontano tra le montagne degli Stati Uniti. Aleksandr Solgenitsin era un matematico “sui generis”, datosi fin da giovane, anima e corpo, alla letteratura. Era l’anti-sistema per antonomasia, colui che mise a nudo le nefandezze del comunismo. “Io volevo difendere le tradizioni russe contro l’uniformismo del socialismo”, disse una volta in un’intervista.
Credente ortodosso, criticato perché considerato a torto un anti-semita, Solgenitsin è una persona che ha pagato duramente per la libertà del suo pensiero: otto anni nei campi di lavoro forzato tra il 1945 ed il 1953 e venti in esilio dopo essere stato cacciato con ignomia dall’Urss nel 1974.
Sono principalmente due i capolavori, che gli fecero acquistare fama mondiale: Una giornata nella vita di Ivan Denisovich, uscita sulla rivista “Novyj Mir” nel 1962, ed Arcipelago Gulag edito in tre volumi del 1973.
Nella prima, pubblicata durante il periodo chruscioviano, l’Occidente scoprì l’orrore del sistema sovietico dei campi di lavoro, da cui passarono milioni di persone. Le descrizioni di Solgenitsin sono terribilmente reali e non lasciano dubbi sulle tragedie raccontate. Per scrivere sulla medesima tematica la sua successiva opera, tradotta in 34 lingue ed edita prima in Occidente e vietata in Patria, l’autore intervistò ben 227 sopravvissuti ai gulag. Le loro identità restarono per anni segrete. Arcipelago gulag è un insieme di fatti storici, autobiografici con testimonianze di vario genere, un documento di accusa drammatico, che gli valse l’esilio. Solgenitsin, allora, aveva già ottenuto il Premio Nobel nel 1970. Il potere sovietico se ne infischiò dello scandalo internazionale che provocò la cacciata dello scomodo scrittore, che tornò in Patria solo nel maggio 1994 per iniziare subito una nuova crociata contro l’oligarchia, la speculazione imperante, la corruzione, insomma contro i mali della Russia post sovietica.
Importanti sono le prese di posizioni di Solgenitsin sulla storia nazionale. Non era vero – sosteneva lo scrittore in pieno contrasto con il mondo scientifico – che la Rivoluzione del 1917, che poi portò ad un sistema totalitario, aveva legami o origine nella cultura zarista di Ivan il Terribile e Pietro il grande. La Russia imperiale non praticava la censura, la polizia segreta era presente solo in tre grandi città ed il potere non era così violento contro la propria gente. L’Urss aveva oppresso la cultura russa in favore di quella atea sovietica. Il nazionalismo russo e la Chiesa ortodossa, quindi, non devono essere considerati oggi in Occidente come una minaccia bensì come un elemento positivo. Da qui, nei primi anni di questo secolo, l’avvicinamento a Vladimir Putin, ex agente del detestato Kgb. La soluzione migliore per il dopo Urss era la creazione di un’entità statale che unisse i tre popoli slavi orientali fratelli: russo, ucraino e bielorusso.
“La morte – ha sottolineato Solgenitsin in una delle sue rarissime interviste – è una naturale pietra miliare, che non segna la fine dell’esistenza di una personalità”. Si può star certi che un posto nell’Olimpo dei Grandi del XX secolo questo matematico, prestato alla letteratura, se l’è certamente guadagnato.
Giuseppe D’Amato
Agosto 2008
Welcome
We are a group of long experienced European journalists and intellectuals interested in international politics and culture. We would like to exchange our opinion on new Europe and Russia.
Categories
- Breaking News (11)
- CIS (129)
- Climate (2)
- Energy&Economy (115)
- EU Eastern Dimension (85)
- Euro 2012 – Sochi 2014 – World Cup 2018, Sport (43)
- Euro-Integration (135)
- History Culture (198)
- International Policy (261)
- Military (74)
- Interviews (18)
- Italy – Italia – Suisse (47)
- Odd Enough (10)
- Poland and Baltic States (126)
- Religion (31)
- Russia (421)
- Survey (4)
- Turning points (4)
- Ukraine (176)
- Российские страницы (113)
Archives
- November 2020
- October 2020
- September 2020
- August 2020
- July 2020
- May 2020
- April 2020
- March 2020
- January 2020
- December 2019
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- July 2019
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- May 2017
- March 2017
- January 2017
- December 2016
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- July 2016
- June 2016
- May 2016
- April 2016
- February 2016
- January 2016
- November 2015
- October 2015
- September 2015
- June 2015
- April 2015
- March 2015
- February 2015
- January 2015
- December 2014
- November 2014
- October 2014
- September 2014
- August 2014
- July 2014
- June 2014
- May 2014
- April 2014
- March 2014
- February 2014
- January 2014
- December 2013
- November 2013
- October 2013
- September 2013
- August 2013
- July 2013
- June 2013
- May 2013
- April 2013
- March 2013
- February 2013
- January 2013
- December 2012
- November 2012
- October 2012
- September 2012
- August 2012
- July 2012
- June 2012
- May 2012
- April 2012
- March 2012
- February 2012
- January 2012
- December 2011
- November 2011
- October 2011
- September 2011
- August 2011
- July 2011
- June 2011
- May 2011
- April 2011
- March 2011
- February 2011
- January 2011
- December 2010
- November 2010
- October 2010
- September 2010
- August 2010
- July 2010
- June 2010
- May 2010
- April 2010
- March 2010
- February 2010
- January 2010
- December 2009
- November 2009
- October 2009
- September 2009
- August 2009
Our books