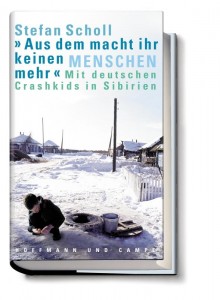All Italiano posts
Russia: tra Occidente ed Oriente – giugno 2008
25 Aug 2009Russia sempre più a due teste: una con lo sguardo verso occidente, l’altra verso oriente. Il primo viaggio all’estero di Dmitrij Medvedev in qualità di presidente della Federazione è stato in Cina. Il segnale lanciato dal Cremlino è chiaro. Se Unione europea e Stati Uniti non ci accoglieranno realmente nel novero delle potenze che contano nell’era della globalizzazione le strategiche materie prime russe prenderanno la strada dell’oriente.
Scelte discutibili o ripicche a parte, l’evidenza è sotto gli occhi di tutti. Dopo il crollo dell’Urss nel 1991 l’ex superpotenza, soprattutto militare, è tornata nel “salotto buono” del pianeta. E’ necessario ora riconoscerlo e conseguentemente accordare a Mosca il posto che le compete. Questo accadde per la Germania all’interno della Comunità europea dopo la Seconda guerra mondiale. Il cammino non è, però, facile: tante sono le incomprensioni, accumulatesi negli ultimi anni, e gli scogli nuovi da superare.
Seguendo la tradizionale linea ambiziosa e connotata da aspetti spesso nazionalistici, il Cremlino intende far emergere nei prossimi anni la piazza di Mosca come uno dei principali centri finanziari del mondo ed il rublo come moneta di riferimento regionale, almeno all’interno delle repubbliche ex sovietiche.
L’obiettivo del “piano Putin” è di far diventare il Paese la sesta economia del mondo entro il 2020. Finora – 2007/2008 – si è riusciti ad entrare nelle prime dieci. Gli Stati Uniti continuano a produrre circa un quarto del Pil del G8, distanziando ampiamente Giappone e Germania. Solo nel 2040, secondo calcoli di alcune agenzie specializzate quali ad esempio la Goldman Sachs, il prodotto interno lordo cinese potrà superare quello a stelle e strisce, sempre che permangano le presenti dinamiche. La Russia resterà distanziata
I sornioni vicini
“Imparate il cinese”. Così Dmitrij Medvedev ai suoi connazionali quando era un semplice primo vice-premier. Da tempo Mosca ha scelto Pechino per controbilanciare Washington e respingere il suo tentativo di intrusione in Asia centrale. Questa alleanza a livello internazionale può essere utile nel breve-medio periodo, ma, nel lungo, potrebbe rivelarsi un boomerang. Lo dicono i grandi numeri. In Siberia vivono solo 30 milioni di russi contro i 200-300 milioni di cinesi ammassati nei pressi della frontiera nord. Una massiccia ondata di immigrati, in caso di inizio di crisi economica a Pechino, è temuta dagli specialisti moscoviti dell’Impero celeste.
Tuttavia, “Il vero problema per noi – sottolinea il professor Viktor Djatlov di Irkutsk – non è il nodo territoriale, bensì l’assoggettamento economico”. L’economia della Siberia e dell’Estremo oriente russo non guarda affatto verso occidente, ossia Mosca. Ormai è dipendente da quella di Pechino.
Il Cremlino ha così dato il via ad un tentativo di riequilibrio della situazione. Ha l’obiettivo di portare il volume complessivo degli scambi da 48,2 miliardi di dollari annui di oggi a 60 entro il 2010. Ben al di sotto, comunque, rispetto all’interscambio sino-americano che, nel 2005, arrivava alla gigantesca cifra di 285 miliardi.
La costruzione di oleodotti e gasdotti verso la Cina va, però, avanti tra le mille difficoltà rappresentate dalla geografia siberiana. Ed il nodo del prezzo delle materie prime non è stato ancora sciolto: i cinesi non intendono pagare quanto richiesto dai russi. Pechino, a differenza di numerosi Paesi del Vecchio Continente, ha sì fame di petrolio e gas, ma è stata abile a diversificare, soprattutto con importazioni da Africa e Kazakhstan. In questo caso è il consumatore a dettare il prezzo non il produttore, incastrato tra complessità tecniche, posizione geografica infelice e concorrenza preparata. Le materie prime di certe aree della Siberia possono essere vendute solo a cinesi o a giapponesi. Ma le coste nipponiche non sono in vista e l’Europa è decisamente troppo lontana.
“Vogliamo un mondo multipolare”, Medvedev ha ribadito, come i suoi predecessori Eltsin e Putin, insieme alle autorità cinesi. Durissimo è stato l’attacco lanciato contro il progetto di dispiegamento dello Scudo spaziale Usa in Polonia e Repubblica ceca. Le cancelliere occidentali sanno perfettamente, anche se qualcuno lo nega ufficialmente, che, in questo mondo globalizzato sempre più incerto per la diminuzione del gap tecnologico tra Paesi ricchi e quelli poveri, si garantisce la propria sicurezza solo investendo continuamente nella ricerca militare, mantenendo così inalterata la propria superiorità.
Chiusi ad ovest – la scelta filo-iraninana ha inciso e non poco -, i russi stanno costruendo centrali nucleari in Cina a man bassa ed hanno stretto un’alleanza spaziale con Pechino per esplorare Marte nei prossimi anni.
Il viaggio di Medvedev nell’Impero Celeste evidenzia che la linea del Cremlino per il prossimo quadriennio non è solo quella della continuità, ma anche del maggiore impegno ad Est. Il compito occidentale è di non buttare troppo la Russia tra le braccia della Cina. Le conseguenze tra un decennio potrebbero essere assai amare.
Gallina dalle uova d’oro?
Stati Uniti ed egoismo occidentale come uno dei responsabili dell’attuale crisi economica; le ricchezze minerarie russe come una delle soluzioni. La ricetta di Dmitrij Medvedev, pronunciata al Forum 2008 di San Pietroburgo, appare nella sua semplicità. Tornano subito in mente passate concezioni imperiali della Russia come “la gallina dalle uova d’oro”. Ma sono tutte rose e fiori come racconta Mosca?
Unione europea ed Usa hanno estremo bisogno delle materie prime russe, non potendo fidarsi della situazione esplosiva in Medio Oriente. Il Cremlino lo sa perfettamente e spera di ottenere il massimo da questa congiuntura strategica internazionale. Le ragioni sono semplici: se vuole essere un giocatore rilevante della globalizzazione la Russia sarà costretta ad investire pesantemente nella vetusta industria estrattiva e soprattutto nelle obsolete infrastrutture (ndr. non esiste nemmeno un’autostrada tra la capitale e San Pietroburgo – distanti come Milano e Roma). Oggi, grazie agli immensi proventi per la vendita di petrolio e gas, Mosca ha le terze maggiori riserve aurifere e valutarie del mondo (quasi 600 miliardi di dollari), ma esse non sono sufficienti a tale gigantesco lavoro da compiere. Finora i capitali occidentali presenti sono stati minimi. Europei ed americani hanno messo ad esempio più soldi nell’economia polacca che in quella russa.
L’anacronistica situazione diplomatica con il Giappone – con il quale non è stato ancora firmato un trattato di pace a conclusione della Seconda guerra mondiale – priva la Russia soprattutto orientale di importanti capitali che farebbero decollare l’economia siberiana.
Giuseppe D’Amato
Giugno 2008
Addio al Patriarca Alessio – dicembre 2008
25 Aug 2009 Con la morte del Patriarca Alessio II si chiude in Russia definitivamente il terribile XX secolo e crolla l’ultimo Muro, quello religioso, nella contrapposizione tra Est ed Ovest.
Con la morte del Patriarca Alessio II si chiude in Russia definitivamente il terribile XX secolo e crolla l’ultimo Muro, quello religioso, nella contrapposizione tra Est ed Ovest.
In queste ore l’ex superpotenza piange uno dei suoi grandi leader, che ha dovuto superare prove difficilissime, ma è riuscito, alla fine, nella sua missione di ridare il giusto posto alla Chiesa ortodossa nella società nazionale. Rispetto ai 18 monasteri e 7mila chiese del 1990, anno della sua elezione, il Patriarcato di Mosca ha oggi 142 diocesi con oltre 27mila parrocchie. La stragrande maggioranza dei 144 milioni di russi si dichiara ortodosso, prima era semplicemente ateo.
Alessio II è stato bravo e fortunato (per l’epoca nuova in cui ha diretto il Patriarcato) a non farsi stritolare nei meccanismi del potere moscovita. Ufficialmente, verso il tramonto della perestrojka, fu il primo capo della Chiesa russa ad essere eletto senza l’intervento del governo. Nel agosto ’91 si scagliò contro i golpisti vetero-comunisti, chiedendo la liberazione di Michail Gorbaciov. Nell’ottobre ’93 Boris Eltsin gli affidò l’impossibile compito di evitare lo scontro armato con il Soviet Supremo. A lungo il Patriarca scomparso è stato il saggio con cui i tre presidenti russi post sovietici hanno potuto consultarsi soprattutto nei tanti momenti difficili che ha passato il gigante slavo.
Vladimir Putin non ha mai fatto mistero di portare al collo una catenina con un crocifisso e non è mai mancato alle cerimonie ufficiali in occasione delle principali ricorrenze religiose. Il giovane Dmitrij Medvedev è notoriamente un credente ed è apparso assai commosso alla notizia della morte di Alessio. Sua moglie Svetlana, l’attuale “first lady”, si è distinta negli anni scorsi in vari progetti di beneficenza collegati alla Chiesa ortodossa.
Sono, quindi, passati secoli da quando il Cremlino dichiarava la guerra “all’oppio dei popoli”. Una bella fetta di merito ce l’ha proprio Alessio II, che è stato accusato più volte di essere stato un collaboratore del Kgb, il servizio segreto. Ma solo chi non ha vissuto sotto al comunismo non può capire quanto fosse complesso avere rapporti con quel tipo di sistema costrittivo. Anche la Chiesa cattolica in Polonia ha avuto disavventure simili.
Ma c’è di più oltre all’aspetto politico. Nel 2000, con l’approvazione della dottrina sociale, la Chiesa ortodossa russa ha tentato pure di scrollarsi di dosso la tradizionale immagine di “braccio” dello Stato, avvicinandosi alle necessità quotidiane dei fedeli.
Durante il suo Patriarcato Alessio II ha tentato in tutti i modi di difendere il proprio territorio canonico dai missionari di altri fedi, rischiando anche l’isolamento persino all’interno del mondo ortodosso orientale. Era conscio che la sua Chiesa, prostrata dal comunismo, non poteva competere con le altre chiese cristiane. Da qui il dissidio con il Vaticano per il “proselitismo” cattolico. E’ stato sempre lui a negare la disponibilità per un incontro con Papa Giovanni Paolo II. Eppure in questi anni la collaborazione a tutti i livelli tra le due gerarchie ecclesiastiche è stata fitta. Mancava sempre quell’ultimo passo decisivo, che si infrangeva davanti all’intransigenza di Alessio II. Adesso si volta pagina. I bocconi avvelenati del passato verranno messi finalmente da parte.
Dicembre 2008
Cernobyl: la tragedia infinita.
25 Aug 2009“Un minuto di silenzio davanti all’icona della Santa Immacolata nel centro storico. Così a Minsk l’opposizione bielorussa ha ricordato il 22esimo anniversario dell’incidente di Cernobyl. La vita di milioni di persone è cambiata completamente da quella terribile notte del 26 aprile 1986. Alla centrale, situata a 120 chilometri a nord-est di Kiev sul confine con la Bielorussia e non lontano da quella russa, era in corso un esperimento quando il reattore numero 4 esplose improvvisamente, disperdendo radioattività in mezza Europa. La peggiore catastrofe atomica civile della storia era avvenuta. Furono milioni gli sfollati.
Ancora adesso non si conosce nemmeno il numero preciso di quanti abbiano perso la vita per questa tragedia, che ha mietuto vittime soprattutto tra i 25mila “liquidatori” accorsi da ogni angolo dell’Urss. I dati sono discordanti e si aggiornano di continuo. Per l’Onu solo 4mila persone morirono, ma le organizzazioni non governative contestano le statistiche ufficiali. Qualcuno azzarda la cifra di 900mila morti a seguito delle conseguenze delle radiazioni. In Ucraina 2,3 milioni di cittadini soffrono ufficialmente delle conseguenze del dramma atomico. Ogni anno centinaia di migliaia di bambini, soprattutto bielorussi, vengono portati all’estero per diminuire le probabilità di sviluppare il cancro alla tiroide.
“Tutti i reattori ad eccezione del quarto sono ormai senza combustibile”, ha affermato in un comunicato la Protezione civile ucraina. La centrale di Cernobyl è stata chiusa solo nel dicembre 2000. I maggiori problemi attuali riguardano il sarcofago che racchiude il reattore esploso con 200 tonnellate di magma radioattivo. Si sta facendo l’impossibile affinché pioggia e neve non entrino all’interno. Presto dovrebbe essere costruito un nuovo contenitore e siti di stoccaggio. L’obiettivo delle autorità è di ripulire completamente l’area entro il 2018. Il segretario dell’Onu Ban Ki-mon ha promesso aiuti per le bonifiche.
Ieri, vigilia della Pasqua ortodossa, all’interno della zona interdetta che si estende fino a 30 chilometri dalla centrale, sono stati fatti entrare gli sfollati, almeno i più nostalgici. In nottata, a Kiev, il presidente ucraino Jushenko ha partecipato ad una funzione religiosa ed ha posto una corona di fiori al monumento dedicato alle vittime.
Nei giorni scorsi il quotidiano filo-governativo Sovetskaja Belarus’ ha ricordato che, quasi sempre con la approssimarsi della ricorrenza, iniziano a circolare le voci più strane. Quest’anno si è parlato di fantasiose fughe radioattive da impianti vicini, costruiti con la stessa tecnologia di quella di Cernobyl.
Nella repubblica ex sovietica il presidente Lukashenko spinge per la costruzione di una centrale per limitare la dipendenza energetica dalla Russia. Nei mesi passati Minsk e Mosca hanno a lungo litigato sul prezzo delle materie prime e sul transito verso ovest. “Chi vuole bene al Paese appoggia il progetto”, ha detto Lukashenko, mentre chi è contro “non sono scienziati, ma banditi della politica, gente che appartiene alla seconda ondata di Cernobyl”.
L’opposizione ha deciso di radunare firme contro qualsiasi centrale. “Questo – ha sottolineato il leader socialdemocratico Nikolaj Statkevich – è per noi un giorno di lutto poiché ricordiamo il passato. Ma è anche una giornata di vergogna, vergogna per il potere che continua a nascondere questa tragedia, potere che il primo maggio 1986 fece scendere in strada la gente per le manifestazioni in onore dei lavoratori”.
26.04.2008
Presentazione Spe salvi in Russia – marzo 2008
25 Aug 2009
“Il documento, il tema ed il risalto dato hanno reso questa occasione un vero evento”. Monsignor Paolo Pezzi è soddisfatto della presentazione della traduzione in russo della Spe salvi. La seconda Enciclica di Papa Benedetto XVI, in cui il Santo Padre spiega cosa è la Speranza cristiana e come essa può salvare, è stata discussa al Centro culturale Biblioteca dello Spirito della capitale dallo stesso arcivescovo cattolico di Mosca e da padre Vladimir Shmalij, segretario della Commissione teologica sinodale del Patriarcato ortodosso.
Una settantina di persone – sacerdoti, professori, giornalisti e fedeli – hanno ascoltato per un’ora e mezza i punti di vista dei due interlocutori. Poi sono seguiti gli interventi di un protestante e di un prete cattolico.
“Siamo stati positivamente colpiti dall’attenzione prestata dalle agenzie di stampa – sottolinea Jean Francois Thiry, uno degli organizzatori della serata -. I commenti sono buoni: cattolici ed ortodossi riflettono insieme”. I tempi delle dure incomprensioni di inizio secolo tra le due Chiese paiono lontani. Si parla sempre meno di proselitismo cattolico e molto di più di ecumenismo. Le differenze, comunque, rimangono. Avvicinamenti confortanti sono spesso seguiti da inspiegabili raffreddamenti. Il tanto atteso storico incontro tra il Papa ed il Patriarca di Mosca resta un sogno di milioni di fedeli. Le diplomazie stanno lavorando, ma il percorso da seguire sembra ancora lungo.
“Gli scritti del Pontefice – continua Jean Francois Thiry – sono accolti favorevolmente anche dagli ortodossi che vedono nel Santo Padre un teologo fedele alla tradizione. Da qui l’idea di questa serata. La nostra casa editrice ha già pubblicato ‘l’Introduzione al Cristianesimo’ del cardinale Ratzinger con prefazione del metropolita Kirill (ndr. Il “numero due” della Chiesa ortodossa russa). La presentazione dell’enciclica papale a due voci è servita per ottenere il pensiero ortodosso sul documento in questione”. Anche la volontà di creare una coscienza ed il desiderio di unità dei cristiani stanno alla base di questi incontri.
Tornando ai due interventi principali, monsignor Pezzi ha avuto un approccio molto pastorale. “Il Papa dice che non si può essere felici nella solitudine e sperare solo in se stessi – ha osservato l’arcivescovo di Mosca -. Il Cristianesimo corrisponde a un fatto, ad un avvenimento, per cui la vita acquista una nuova prospettiva. Siamo salvati dalla speranza; la vita può avere un senso, un senso che salva. E se salva vuol dire che è presente, non può essere lontano. Nella speranza siamo certi, la speranza è legata alla certezza: di solito la colleghiamo a qualcosa di incerto e futuro, che verrà. Ed invece no, possiamo già viverla ora. Dove troviamo questa speranza? Nell’esperienza di chi ha già questa speranza; ci sono dei testimoni che fanno già esperienza di speranza. Il Papa indica due tipi di testimoni: 1. la Bibbia, che descrive il rapporto Dio-uomo, non è una parola astratta; 2. i testimoni viventi che sono i Santi. Ci serve la fede per sperare”.
“Dobbiamo adesso – ha proseguito monsignor Pezzi – farci la domanda se la fede ci dà vera conoscenza di Cristo. Se non è così anche la speranza è vana. È necessario il coraggio di alcuni che portino la speranza per tutti. La speranza è legata al desiderio dell’uomo. Il Papa propone di allargare il desiderio, che nell’uomo è desiderio di felicità. La speranza è legata anche al sacrificio. Per tutti, di solito, il sacrificio è una tragedia, ma, in un determinato momento della storia, è diventato una parola grande: quando Cristo è andato in croce! L’uomo ha così tanto valore per Dio che Dio ha deciso di farsi uomo e soffrire per l’uomo. La speranza è legata anche alla nostra responsabilità, rispondiamo di quello che abbiamo ricevuto nel Battesimo”. Seguendo l’esempio della Madonna, ha concluso monsignor Pezzi, “la vita è una chiamata; c’è un posto dove Qualcuno mi chiama, e io rispondo!”
Padre Vladimir Shmalij ha, dal suo canto, evidenziato che questa è stata la prima volta che un’enciclica è stata presentata in Russia. “Essa è una sorta di messaggio apostolico mandato a tutti. Non è rivolta solo ai cristiani e ai credenti, ma ad ogni uomo”, ha detto il rappresentante ortodosso.
“La speranza – ha sostenuto don Shmalij – è fondamentale perchè è legata alla domanda: perchè vivo? La speranza è una realtà oggettiva. La speranza non sta nel progresso tecnico e scientifico e non è un nostro atteggiamento psicologico, ma è ciò che acquistiamo con il Battesimo. E’ una realtà”. Secondo il prelato ortodosso il Papa “non si pone come critico feroce della nostra società. La sua è una critica leggera. Critica l’individualismo cristiano; la nostra speranza in Dio non è come dovrebbe essere; Cristo dovrebbe essere il fondamento della nostra vita. È difficile far corrispondere l’immagine splendente di speranza da cui siamo bombardati dalla società con le condizioni in cui poi viviamo tutti giorni. I cristiani non possono non reagire di fronte a questo”. Quello del Papa è – in sostanza – un grande richiamo per i cristiani.
Marzo 2008
Prilepin: Uno scrittore controcorrente
24 Aug 2009 “Il potere in Russia non ha bisogno del popolo”. Zakhar Prilepin è il miglior prodotto delle nuove generazioni letterarie. I riconoscimenti, ottenuti da questo giovane 32enne di Nizhnji Novgorod, iniziano a non contarsi più. Tre i libri di maggior successo: Patologija, Sankja, Peccato. Alcune sue opere sono in pubblicazione anche all’estero, in particolare in Germania.
“Il potere in Russia non ha bisogno del popolo”. Zakhar Prilepin è il miglior prodotto delle nuove generazioni letterarie. I riconoscimenti, ottenuti da questo giovane 32enne di Nizhnji Novgorod, iniziano a non contarsi più. Tre i libri di maggior successo: Patologija, Sankja, Peccato. Alcune sue opere sono in pubblicazione anche all’estero, in particolare in Germania.
Guardia del corpo poi giornalista e scrittore, Prilepin si è iscritto dal 2001 al partito nazional-bolscevico (PNB). Calvo, di media altezza, ma nel complesso robusto è stato spesso fermato o arrestato dalla polizia per la partecipazione a marce di protesta contro il Cremlino.
Lei è considerato uno scomodo. Come è riuscito ad emergere? “Il potere – commenta Prilepin, fumando lentamente una sigaretta – guarda la televisione e non legge più, per mia fortuna”.
Come definisce la Russia di inizio secolo? “Un Paese che vive un momento di difficoltà. Le élite hanno deciso di comandare, infischiandosene della volontà popolare. E c’è poi una grande differenza tra ciò che dicono e ciò che fanno in realtà. Putin non ascolta il popolo”.
La sua attività politica le ha creato non pochi problemi. “Io sono un uomo libero, per di più di successo. La polizia mi ferma in continuazione. L’Fsb ascolta le mie telefonate. Tutto ciò mi fa ridere. Ormai mi sono abituato a certe situazioni. Dovrei essere un isterico ed invece sono felice della mia vita. Ho stabilito di essere libero e di dire quello che penso”.
Perché da ragazzo è andato a combattere in Cecenia nelle file degli Omon. “Per interesse. Forse come Lermontov e Tolstoj per spirito di avventura. Quella era una guerra senza regole. Per fortuna non ho assistito a violazioni o crimini. E non ho ammazzato nessuno. Chi era con me si è comportato con onore”.
Ha avuto paura laggiù in Caucaso? “No. I soggetti dei miei libri hanno questo sentimento. La cosa peggiore che possa succedere è che gli uomini perdano la loro faccia ed il loro onore. Vi è sempre la lotta per non passare quel confine e rimanere uomini”.
Cosa cerca in un partito estremista come il nazional-bolscevico? Vi si è iscritto subito dopo il ritorno dalla Cecenia. “Non è vero che il PNB sia fascista. Mi piace la sua estetica. Si ha la possibilità di parlare e di rispondere delle proprie parole. Allora cercavo la gente, i valori spirituale e non materiali”.
Ma perché non si è rivolto alla Chiesa? “Sono un laico. Credo in Dio”.
E adesso quale è il suo compito da militante politico? “Difendere la gente dalla leadership. Mostrare il coraggio della società civile. Il potere si comporta in modo vergognoso: le recenti legislative sono state falsificate. Per ora la gente pensa che questo vada bene lo stesso. Poi ci sarà un momento in cui scoppia come un vulcano”.
I russi si stanno arricchendo. Pare poco preventivabile una rivoluzione o un cambio di potere. “Per uno scoppio basta il 5% della popolazione. Anche tra i moscoviti e tra gli imprenditori ci sono degli insoddisfatti. Le élite non vogliono dividere le ricchezze del Paese. Senza Putin esistono tanti clan con interessi diversi tra loro. Il presidente è stanco delle grane interne. Vorrebbe dedicarsi ai grandi incontri internazionali, che so al G8. Non glielo permettono”.
Giuseppe D’Amato
primavera 2008
Un’automobile tutta d’oro
24 Aug 2009Mosca. Zio Paperone abita di certo a Mosca. Ne è convinto il quotidiano Komsomolskaja pravda che ha scoperto che in città gira una Porsche 911 con la carrozzeria d’oro. In un primo momento si è pensato ad uno scherzo, ad una verniciatura andata male. Ed invece è tutto vero. Il giornale ha pubblicato varie fotografie dell’automobile su cui Re Mida si è appoggiato.
Gli sforzi di parlare con il proprietario del gioiello sono andati a vuoto. L’uomo, che si è comprato un paio di anni fa un appartamento in un semplice palazzo di cinque piani alla periferia sud-occidentale della capitale, è “un tipo taciturno”. Così lo descrivono i vicini, che, però, riferiscono che il Paperone, di professione manager in una società di commercialisti, raramente pernotta in quella casa. La Porsche 911 dorata è stata vista nei parcheggi dei più lussuosi casinò e ristoranti moscoviti.
Una successiva indagine ha stabilito che, per la carrozzeria della macchina, sono stati utilizzati ben venti chili di oro puro. Soltanto il valore del metallo prezioso usato si aggira sui 14 milioni di rubli, circa 390mila euro. A questo si deve aggiungere il lavoro degli specialisti automobilistici, dei cesellatori e quello dei designer. E chissà poi quale è il costo della polizza d’assicurazione in caso di furto.
L’ostentazione della propria ricchezza, spesso maleducata e cafona, è la caratteristica più marcata dei “nuovi russi”, circa centomila supermilionari e qualche centinaio di miliardari che, in barba alle difficoltà finanziarie di molti connazionali, fanno a gara a distinguersi dagli altri dopo decenni di uniformità comunista.
Nei primi anni post sovietici le tazze del water d’oro delle toilette nelle ville nuove di zecca erano abbastanza comuni. Adesso ci si limita a parquet aurei, a telefonini od orologi esclusivi pieni di diamanti e pietre preziose. Ma certo la Porsche dorata supera qualsiasi stravaganza, persino, l’ultima in ordine di apparizione, quella delle hostess con sul viso una specie di crema d’oro zecchino.
Ci immaginiamo l’auto di zio Paperone tentare di sfrecciare nel traffico infernale di Mosca mentre provoca l’invidia dei tanti che si credono “già arrivati” – e guidano solo un’utilitaria straniera o l’ultimo modello di Suv da centinaia di migliaia di dollari – e di quelli che vogliono, ma non posso a bordo delle anti-diluviane Lada, modello sovietico.
Dopo qualche giorno dalla pubblicazione della foto della Porsche d’oro sui giornali un uomo d’affari di Kazan, centro a circa 700 chilometri dalla capitale russa, ha portato nella stessa carrozzeria moscovita un’“Infiniti”, comprata per la moglie Liudmila alla sua quarta gravidanza, a cui sono stati applicati vari chili di argento. Poi solito lavoro dei cesellatori e quello dei designer. Costo dell’operazione circa 70mila euro. L’auto è stata ricondotta a Kazan durante un temporale, in maniera tale che i poliziotti della strada, che in Russia hanno una sinistra fama, non prestassero troppa attenzione alla macchina e non chiedessero mazzette. La signora Liudmila potrà adesso mostrare ai suoi concittadini il suo status symbol di ricca moglie di un businessman. Certo che al quinto figlio una placchetta d’oro ci potrebbe pure scappare!
Autunno 2008
Nikolajewka (oggi Livenka) – Eccola finalmente! Generazioni di italiani hanno sentito parlare di questa località sperduta nella steppa russa. E’ qui, come ad El Alamein o a Tobruk, che migliaia di nostri ragazzi hanno scritto una pagina eroica e drammatica della storia d’Italia, il 26 gennaio del ‘43.
Oggi è giorno di mercato. La via principale, per metà asfaltata e per metà in terra, è piena di camion che scaricano merci d’ogni tipo. La gente si accalca nella polvere. E’ vestita in maniera assai sobria e povera, tipica dei contadini della Russia meridionale. Tre villaggi agricoli, unitisi in questo minuto pianoro fra le colline, costituiscono il paese, oggi conosciuto come Livenka. Le case a ridosso della ferrovia per l’Ucraina formano Nikolajewka, denominazione segnata sulle carte militari italo-tedesche, basate a loro volta su quelle russe della Prima guerra mondiale.
Niente ricorda la battaglia campale di 60 anni fa. Solo fuori paese in un prato nascosto, dove si trovava una fossa comune, Onorcaduti ha eretto una lapide. La nostra guida, il prof. Alim Morozov, ci fa visitare due sottopassaggi da cui sono passati parte delle truppe alpine e la stazione ferroviaria (oggi denominata Palatovka), dove i nostri hanno sfondato. <<E’ stata la vittoria della disperazione, della rabbia, della voglia di tornare a casa. O si passava o si moriva>>, ci ha raccontato il giorno prima a Rossosch, Guido Vettorazzo, allora poco più che ventenne, uno dei pochi della “Julia” che si è salvato. L’abbiamo incontrato nell’ufficio del sindaco in compagnia di tre altri “veci”. La vista dei loro bei cappelli con la piuma ci ha lasciato per qualche secondo senza parole.
|
|
Circa 5mila sovietici con mortai, cannoni e mitragliatrici avevano trasformato il terrapieno della ferrovia di Nikolajewka in un formidabile sbarramento, ci spiega la nostra guida. Alle 9,30 del mattino del 26 gennaio inizia l’assalto disperato degli italiani insieme a qualche reparto tedesco ed ungherese, forse 40-50mila uomini, male armati, mezzi congelati, affamati.
Alle 16 è già buio. Non si passa. Rimanere all’addiaccio avrebbe significato morire al gelo o arrendersi, dopo 10 giorni di marcia forzata nella neve, proprio a due passi dalla salvezza. All’improvviso il miracolo. Il generale Reverberi, comandante della “Tridentina” salta su un tank tedesco e grida <<Tridentina, avanti!>>, mettendo di nuovo in moto gli alpini ormai sfiniti. <<Né io né Guido abbiamo sentito quel grido – ricorda Adolfo Lovato della “Tridentina” – ma abbiamo visto una massa enorme di gente andare all’attacco>>. Così, combattendo all’arma bianca, gli alpini hanno sfondato e sono usciti dalla sacca in cui i sovietici li avevano chiusi.
Il corpo d’Armata alpino, diretto in un primo momento sulle montagne del Caucaso, era stato ridislocato a controllare le difese trincerate sul Medio Don nel settembre ‘42. Aveva stabilito il suo comando a Rossosch, allora centro con 14mila abitanti. <<La nostra era una missione pompata – sottolinea Vettorazzo -. Dopo la Grecia il fascismo si era inventato la Russia>>.
Ben presto, con il sopraggiungere dell’inverno, gli ufficiali si rendono conto dell’inadeguatezza dell’equipaggiamento. I maggiori problemi sono legati alle calzature. Roma cincischia su questioni di look. Così gli alpini sono costretti a scambiare con la popolazione locale cibo per vestiti e valenki (stivali caldi russi). Col gelo le armi e i camion non funzionano più. Sul piano militare, malgrado le assicurazioni alleate, gli italiani capiscono di essere vulnerabili, poco adatti ad una guerra in pianura. I tedeschi devono garantire la mobilità dell’intero schieramento di difesa sul Don.
Il 14 gennaio ’43 accade l’impensabile: malgrado il tempo inclemente i sovietici attaccano di sorpresa da sud con centinaia di tank, sbaragliando il 24esimo corazzato tedesco, prendendo le altre divisioni alle spalle. La frittata è fatta! Il giorno dopo gli alpini si ritrovano i carri armati di Stalin fin dentro Rossosch. Arrivano anche le truppe a bordo di jeep americane e camion speciali Usa trasportano l’artiglieria pesante. Il comando italiano dà l’immediato ordine di ritirata dal Don alla “Julia”, alla “Cuneense”, alla divisione di fanteria “Vicenza” ed alla “Tridentina”.
|
La ritirata – Museo del Medio Don |
E’ l’inizio del calvario. <<Abbiamo ripiegato nel miglior modo possibile, all’improvviso>>, commenta Lovato. Gli alpini abbandonano la maggior parte delle armi pesanti ed i veicoli. In poche ore i carri armati sovietici prendono il controllo delle strade principali, costringendo gli italiani a ritirarsi verso occidente in una folle corsa di circa 150 chilometri attraverso campi gelati e paesini sperduti per uscire dall’accerchiamento. Le imboscate sono frequenti, gli atti di eroismo non si contano. <<La temperatura doveva essere di giorno sui meno 20, di notte intorno ai meno 35 – sostiene Morozov -, ma il vento faceva sentir ancora di più il freddo. Nei campi c’era una sessantina di centimetri di neve, che, però, non era uniforme ed, in alcuni punti, poteva arrivare fino alle spalle>>.
In un primo momento, l’ordine è di ritirarsi verso Valuiki, che, però, è già stata occupata il 17 gennaio dai 10mila cosacchi. Ed è lì che finiranno annientati i resti della “Julia” e della “Cuneense”, 10 giorni dopo. <<Questo dà il senso dell’ignoranza dei nostri alti comandi – accusa amaramente Vettorazzo -. I collegamenti radio fra le divisioni non funzionavano>>. La confusione più totale che, dopo 60 anni, non ha trovato ancora una necessaria analisi critica fra i nostri militari. La “Tridentina”, invece, viene a sapere della situazione a Valuiki ed il generale Gariboldi dà ordine il 21 a Sheliakino di cambiare direzione e marciare su Nikolajewka. La colonna degli italiani, molti sbandati senza armi e a bordo di slitte di fortuna, è ormai lunga 40 chilometri con quello che rimane della “Cuneense” in retroguardia.
<<Lo scontro più sanguinoso che hanno avuto gli italiani in Russia è avvenuto il 20 gennaio qui a Novopostojalovka non a Nikolajewka – afferma sicuro Morozov, mentre ci mostra la strada dove era posizionata l’artiglieria sovietica e le izbe dove si erano nascosti i soldati di Stalin -. Circa duemila i morti in 30 ore con la “Cuneense” e la “Julia” praticamente decimate, costrette ad attaccare in campo aperto, per di più pieno di neve>>. In pratica, un vero suicidio. Gli italiani vengono respinti. Ma, poco più a nord, a Postojalyi, la “Tridentina”, arrivata da Podgornoje ed ancora efficiente, ha aperto una breccia.
Percorriamo la strada fino a Nikolajewka, passando per Warwarowka, Nikitowka, Arnautovo. E’ un susseguirsi di colline più o meno soavi e pianure che assomigliano ai nostri altipiani. Villaggi e fattorie si alternano spesso nel nulla. Ovunque si osservano mandrie di vacche e gruppi di oche che passeggiano lungo le strade. I russi viaggiano spesso a bordo dei trattori o su dei modelli superati di sidecar.
 Davanti all’asilo di Rossosch. Da sinistra, Periz, Lovato, Morozov, Leonardi, Vettorazzo. Davanti all’asilo di Rossosch. Da sinistra, Periz, Lovato, Morozov, Leonardi, Vettorazzo. |
Gli italiani sostengono che il nemico era in numero nettamente superiore. Qualcuno azzarda a dire 1 a 10, 1 a 14. I sovietici affermano esattamente il contrario. Ed infatti in alcuni paesini, ci dice Morozov, sono stati costretti ad arruolare gli adolescenti della locale “gioventù comunista”. E’ evidente che la strategia dei generali di Stalin è stata vincente.
Il risultato finale è che la maggior parte delle Armate italiane è stata fatta prigioniera quasi senza combattere. Il balletto delle cifre cambia a seconda della fonte. 25-30mila i caduti in ritirata. L’ecatombe in Russia è avvenuta soprattutto fra i circa 70mila prigionieri o forse più, morti quasi tutti fra gennaio ed aprile ’43 per fame e freddo prima di arrivare ai lager, molti oltre gli Urali in Siberia. I sovietici non erano preparati ad accogliere tanta gente. Il cibo mancava anche per loro. Gianni Periz ci mostra alcuni dati, semplicemente agghiaccianti: solo 10mila prigionieri italiani sono tornati a casa dai lager sovietici.
All’appello, quindi, mancano in totale circa 100mila nostri militari. <<E’ difficile ricostruire i nomi dei caduti – ci spiega il maresciallo Andrea Muzzi, del Commissariato generale delle FFAA, incontrato per caso in albergo a Rossosch, dove stava programmando il piano per le esumazioni per l’anno in corso -. I carcerieri russi annotavano i nomi dei morti italiani in cirillico sui registri dei lager, chiedendo ai prigionieri il nome del deceduto e trascrivevano quello che capivano>>.
L’identificazione dei caduti è qualcosa, spesso, di impossibile. <<Come ci hanno detto i reduci – sottolinea da Roma il colonnello Paolillo – i nostri militari si levavano le piastrine: erano fastidiose! Queste erano di rame, così se oggi vengono ritrovate sono illeggibili>>.
Qualcuno dei dispersi può aver trovato rifugio in qualche fattoria, chiediamo ai due reduci alpini e a Morozov. La risposta è secca: <<No. Sono leggende cinematografiche>>. <<Allora il controllo delle truppe sovietiche – ci spiega la nostra guida russa – era ferreo. Conosco parecchi casi di italiani curati dai russi, ma poi consegnati alle autorità>>
Ogni tanto salta fuori qualche nuovo reperto: per caso, di recente, è stata ritrovata la gavetta del papà del sindaco di Cairo Montenotte (SV), Osvaldo Chebello, che è andato di persona a riprendersela. Nei racconti dei russi il disgelo quell’anno fu terribile: donne e bambini vennero mandati a sotterrare i cadaveri, che, per il timore di malattie, vennero buttati in fosse comuni, ora attivamente ricercate, tra mille difficoltà, dal programma di esumazione governativo italo-russo.
Circa 8mila caduti sono tornati in Italia e riposano nel sacrario di Cargnacco in Friuli.
Seguendo il motto <<ricordare i morti, aiutando i vivi>> gli alpini dell’Associazione nazionale (ANA) hanno costruito a Rossosch tra il ’92 ed il ’93 un asilo per i bambini russi. L’“operazione Sorriso” ha mobilitato 773 volontari, divisi in 21 turni. Tutto il materiale necessario è stato portato dall’Italia. <<Non vogliamo monumenti – ha detto allora il bergamasco Leonardo Caprioli, presidente dell’ANA -. Coi russi dobbiamo ritrovarci nell’infanzia>>.
Lo studioso: Alim Morozov
Rossosch – Nel Medio Don lo studio della Campagna di Russia prosegue senza intervalli. Il professor Alim Morozov gestisce con grande impegno un museo (il Museo del Medio Don) all’interno dell’Asilo, proprio dove era dislocato il Comando d’Armata alpino durante la Campagna di Russia. <<Abbiamo organizzato a Rossosch – ci racconta Morozov – una conferenza per il 60esimo anniversario degli eventi del ‘43. Hanno partecipato anche alcuni veterani russi. Invero sono rimasti in pochi, quasi tutte donne: soprattutto infermiere>>.
Mi levi una curiosità, Signor professore. Perché i prigionieri dell’Asse sono stati trasferiti ai campi di concentramento in un primo momento a piedi, con le tragiche marce del “davai” e non con i treni. Dopo tutto Rossosch è un nodo ferroviario strategico. <<Tutti i binari nei territori occupati erano stati cambiati con quelli di misura europea. Erano più stretti (di dieci centimetri) dei nostri a scartamento ridotto. I nostri treni non potevano viaggiare in quelle zone>>.
Però che efficienza, in così poco tempo… <<Le truppe di occupazione hanno utilizzato la popolazione civile ed avevano a disposizione reparti specializzati. Subito, hanno eseguito questo cambiamento ed in alcuni distretti hanno persino costituito nuove reti ferroviarie. Solo in primavera inoltrata (1943) i nostri treni hanno ripreso a viaggiare>>.
Quindi, questa è la vera ragione delle marce del “davai”? <<Nei mesi invernali la movimentazione delle truppe sovietiche d’attacco è avvenuta non per ferrovia. I territori adiacenti a quelli occupati non avevano reti ferrate per centinaia di chilometri>>.
Giuseppe D’Amato
—
In russo Битва Николаевки
Rada: Il Lager degli Italiani
In russo Ледяной ад Рады
Vedi anche Museo del Medio Don in DonItalia
In italiano Campagna di Russia, 70 anni dopo. Il ricordo nelle terre dove si è combattuto
Museo del Medio Don – Rossosch
Rada. Casella postale 188, Unione Sovietica -. L’aria è gelida. Il sole splende, ma non scalda. La neve arriva in certi punti quasi alle ginocchia. Aleksandra Stepanova Krushatina avanza senza indugio in questa foresta fittissima di querce e di pini. Malgrado i suoi 79 anni, il passo è sicuro, grazie anche ai “valienki” neri, tipici stivaloni russi di feltro, che ha ai piedi. <<Ecco, i prigionieri di guerra dormivano lì>>, ci indica rossa in volto per il gelo, dopo cinque minuti di passeggiata, un fossato pieno di neve, dove sono ancora visibili dei pali piantati nel terreno. Qui, a sei chilometri dal lager, si fermava per la notte una delle tante squadre che tagliavano le querce, il cui legno serviva all’Armata rossa per costruire ponti o veniva utilizzato nelle miniere del bacino carbonifero del Donbass in Ucraina orientale.
Sessanta anni fa avveniva in Russia il più grande disastro della storia militare italiana e la maggiore ecatombe di nostri soldati di tutti i tempi. In tre fasi, tra il novembre ’42 ed il gennaio ’43, l’esercito sovietico circondò e mise fuori combattimento le truppe dell’Asse a Stalingrado e sul Don. Solo parte del Corpo d’armata alpino riuscì a ripiegare, rompendo l’accerchiamento a Nikolajewka il 26 gennaio ’43. L’avventura dell’Armir finiva lì, col successivo rimpatrio in primavera: secondo dati sovietici, in quei terribili mesi, morirono combattendo o di stenti circa 25mila soldati italiani, mentre approssimativamente 70mila furono fatti prigionieri. Per quest’ultimi iniziò un’odissea infernale. Solo 10.030 di loro tornarono a casa tra la fine del ‘45 ed il ’54.
<<Non capivamo cosa dicevano i prigionieri. Ce ne erano di tutte le nazionalità>>, racconta Aleksandra, ancora molto lucida nei suoi ricordi, nella sua isba di legno, arredata come se il tempo non fosse mai passato. Alcuni prigionieri in divise gialle” lavoravano con la popolazione civile. <<Ma perché dovevano scappare? E poi dove? Dopo tutto avevano da mangiare>>, dice la donna seduta vicino ad alcune immagini sacre. <<I rapporti con loro – aggiunge Aleksandra – erano buoni: vi era anche un piccolo commercio di oggetti che venivano scambiati per cibo>>. Episodi particolari? <<Una volta ero con la mia amica Julia vicino alla stazione. Alcuni dei prigionieri ci gridavano in russo di avvicinarci ai vagoni. Volevano abbracciarci e proponevano di baciarci. Dopo tutto anche loro erano dei ragazzi giovani>>.
L’ecatombe per gli italiani si ebbe nei primi 6 mesi di prigionia. La mancanza di ferrovie a scartamento ridotto obbligò i sovietici a sgomberare a piedi i prigionieri per centinaia di chilometri su strade innevate durante la stagione dei “morozy” (gelo) con temperature glaciali. Tanti sono i racconti tragici dei nostri sopravvissuti delle “marce del davai (in russo: forza, avanti)”, che si portarono dietro una spaventosa scia di sangue con soldati esausti, morti per la fame e gli stenti, o fucilati dalle guardie sovietiche. Una volta giunti alla ferrovia, i prigionieri venivano stipati come sardine in vagoni bestiame. Il viaggio durava giorni o settimane con scali eterni, quasi senza cibo ed acqua. Quando il treno raggiungeva i campi di smistamento e venivano aperti i vagoni piombati, erano più i morti che quelli rimasti vivi.
E’ proprio in questa foresta che verso il Natale del ’42 arrivarono, mezzi congelati e vestiti di cenci, i primi fanti dell’Armir, riempiendo uno dei più grandi campi di concentramento dell’Urss, il lager 188 di Rada, nei pressi di Tambov, circa 480 chilometri a sud-est di Mosca. Accanto alla stazioncina ferroviaria c’è la prima fossa comune.
In sei mesi, dal dicembre del ’42 entrarono a Rada 24mila prigionieri, di cui 10.118 italiani. Il lager non era attrezzato per accogliere tanti uomini, gli stessi carcerieri dormivano in ricoveri di fortuna. La mortalità era altissima: 1.464 a gennaio, 2.581 a febbraio, 2.770 a marzo. In 10 mesi sono state registrate 14.433 morti. La percentuale dei deceduti fra gli italiani del campo 188 è spaventosa: oltre il 70%.
I racconti dei sopravvissuti di quel periodo sono semplicemente agghiaccianti: fame, freddo, malattie. Mancava tutto, fino alle cose più elementari. Le risse per un pezzo di pane erano frequentissime. I morti non venivano nemmeno sepolti, così gli uomini del bunker avevano una porzione in più da mangiare. L’abbrutimento era completo. Il lager diventò presto un letamaio ed un lazzaretto: la dissenteria faceva strage insieme al tifo petecchiale. I pidocchi non davano tregua e non si riusciva in nessun modo a debellarli.
Il campo di concentramento di Rada venne creato alla fine del ’41: i sovietici avevano bisogno di un luogo per filtrare i propri soldati o partigiani “liberati”, sospettati di collusione col nemico per il solo fatto di essere stati catturati. I prigionieri vivevano in specie di bunker, grandi buche nel terreno (13 metri per sette) e una tettoia appena fuori terra, in grado di ospitare 80 uomini. Col tempo, il campo si allargò e le condizioni di vita decisamente migliorarono. Si riuscirono a celebrare persino le Sante messe a Pasqua e Natale. Nel ’47 Rada venne chiusa. <<Probabilmente per un litigio tra Stalin ed il generale De Gaulle – sostiene la nostra guida, Evghenij Pisarev -. E’ qui che erano tenuti prigionieri gli alsaziani e i loreni che Hitler aveva reclutato con la forza. Alcuni di loro furono spediti a combattere in Africa>>.
L’Nkvd, la polizia segreta sovietica, distrusse il campo, cancellando ogni traccia, e la zona rimase chiusa, segreta, anche per la presenza nelle vicinanze di un poligono di tiro. <<Dimenticate!>> fu l’ordine impartito dalla Lubjanka. Tutte le cartelle personali dei prigionieri di Rada furono spedite all’Archivio militare di Mosca, dove rimangono gelosamente custodite. Ed <<è quasi impossibile consultarle – mette in chiaro lo storico moscovita Nikita Okhotin, che ha condotto studi sui comunisti italiani uccisi da Stalin -. Il ministero della Difesa italiano ha comunque ricevuto, agli inizi degli anni Novanta, delle microfiche con alcuni elenchi dei vostri militari>>.
Elenchi che sono purtroppo in cirillico ed i cognomi sono difficili da decifrare e spesso non corrispondono a quelli dei soldati dell’Armir. A Tambov, città famosa per i lupi, all’archivio regionale è rimasto un fondo, dimenticato dal solito pressappochismo russo. <<Vi sono 44 cartelle con dati generali: ordini, elenco di materiale ed equipaggiamento. Le ritrovammo per caso intorno al 1990>>, ci dice l’archivista Tatjana Krotova, che ci mostra anche il rapporto sulla cattura di due fuggiaschi italiani, Felice Celoti (classe 1918) – classificato come antifascista – ed Angelo Calzani (1920), arrestati a 25 chilometri da Rada.
Avanziamo tra la neve, alta un palmo, nel cimitero memoriale, inaugurato nell’agosto ’98, sul lato esterno del campo. Dopo decenni la memoria ha avuto finalmente il sopravvento sull’oblio. E lo storico pellegrinaggio di Carlo Azelio Ciampi, il 29 novembre 2000, ha contribuito enormemente a ricordare quei tragici anni. I cittadini di Tambov non dimenticano e parlano del presidente italiano con grande ammirazione. <<Qui – sottolinea Pisarev – non è mai venuto nessuno: né Eltsin né Putin né altri leader stranieri. Il vostro presidente sì>>. Il futuro capo dello Stato fu mandato nell’autunno ’42 a combattere in Albania nel corpo degli autieri, ma avrebbe potuto essere dirottato in Russia, proprio quando il fronte del Don crollava.
E’ l’una. La temperatura è ben oltre i 20 gradi sottozero. Insomma sono le stesse condizioni climatiche trovate dai nostri militari 60 anni fa. Vi sono vari cippi commemorativi a ricordo delle migliaia di soldati, appartenenti a 29 nazionalità differenti (molti erano anche alleati dei sovietici: inglesi, americani, polacchi!), passati per Rada o sepolti qui intorno nelle gigantesche fosse comuni. Qui riposano per sempre tra 10 e 15mila nostri ragazzi. Di molti di loro non si conosce nemmeno il nome.
Scopriamo dalla neve il cippo italiano. Il luogo lascia il visitatore senza parole ed incute commozione. Nella mente tornano le parole pronunciate da Ciampi a Tambov nel 2003: <<Gli Stati multietnici sono uno scudo contro le barbarie. Se non si tiene viva la memoria ogni cosa terribile del passato può tornare a ripetersi>>.
Il personaggio: Pisarev
Tambov – <<Spesso non c’è una logica>>. Evghenij Pisarev è il massimo studioso russo del campo di Rada. La sua curiosità l’ha frequentemente messo nei guai soprattutto con l’omertoso potere sovietico locale, a metà degli anni Ottanta. La verità doveva, però, venire a galla ed il suo contributo è stato rilevante. <<Secondo me – afferma il 56enne giornalista, autore di un libro sul campo 188, – nelle fosse comuni di Rada ci sono almeno 50-60mila morti. Ufficialmente ce ne sono molti meno, ma quei documenti non sono veritieri. Per coprire l’alta mortalità, l’Nkvd diede ordine di utilizzare la dicitura “trasferito”>>.
|
Pisarev davanti all’archivio di Tambov
|
La presenza dei nostri militari è stata segnalata in oltre 400 lager dislocati su tutto il territorio sovietico. Continue furono le loro peregrinazioni, quasi senza senso, per l’Urss: dalla gelida Siberia all’afoso Uzbekistan, dal confine cinese all’Ucraina. Ai soldati dell’Armir, catturati sul Don, bisogna aggiungere anche i nostri militari, fatti prigionieri dai tedeschi su altri fronti e “liberati” dall’Armata Rossa, ma finiti nei campi di concentramento di Stalin. In totale, dai dati del Commissariato del ministero interno dell’Urss, dai 5mila luoghi di detenzione passarono 6 milioni di persone provenienti da 30 Paesi.Nell’inverno ’42 i sovietici non erano assolutamente pronti a dover gestire in poche settimane ben mezzo milione di prigionieri. Vi era in loro una volontà distruttiva sui vinti? <<No – dice Pisarev -. Non c’è mai stata. Ad esempio, il lasciare giornate intere i treni fermi sui binari con la gente pigiata nei vagoni senza cibo ed al gelo è un elemento tipico del solito casino russo, della disorganizzazione, del menefreghismo. L’unica attenuante è la guerra>>. I prigionieri stranieri hanno provato sulla propria pelle, né più né meno, quello che vivevano quotidianamente i cittadini sovietici. Ed è andata loro ancora bene. <<Non bisogna dimenticare – continua il nostro interlocutore, spesso balbettando, – che, negli anni Trenta, Stalin ha ucciso forse 20 milioni di persone. I prigionieri sovietici dei tedeschi, una volta nelle mani dell’Armata Rossa, sono finiti nei lager. Molti sono stati fucilati come traditori>>. Perché ci sono stati così tanti morti fra i militari italiani? <<Siete gente del sud – sostiene Pisarev -, non abituati al nostro clima ed alla nostra alimentazione. Per di più senza nemmeno il vestiario adatto. Hitler è stato un pazzo a volere gli italiani in Russia. Per fortuna la popolazione locale vi ha ben accolto ed aiutato, altrimenti quei poveracci morivano tutti>>.
Testimoni scomodi
Tambov – Basta visitare il sito Internet dell’Associazione nazionale reduci di Russia per capire il perché l’Italia ha sempre cercato quasi di minimizzare la tragedia di 60 anni fa: non si volevano aprire ulteriori ferite. Poco chiaro è, infatti, il ruolo avuto dai fuoriusciti italiani sia nei campi di detenzione sia a Mosca, nel perorare la causa dei propri connazionali presso il potere sovietico. Alcuni di loro sono stati deputati e senatori della Repubblica nel dopoguerra. I francesi hanno messo da parte le dispute ideologiche passate, riuscendo a farsi un quadro preciso della tragedia in Russia con tanto lavoro negli archivi. Gli italiani, invece, non ancora. Il quindicennale “L’Alba” e Radio Mosca sono stati a lungo per i nostri prigionieri l’unico mezzo per sapere cosa succedeva nel mondo. Nei campi si trovavano solo pubblicazioni e libri comunisti in italiano. <<Nei lager – ci spiega Pisarev – vi erano agenti infiltrati, che cercavano potenziali futuri adepti da mandare alla scuola antifascista di Mosca e poi all’estero>>.
Nelle cartelle personali vi era la voce sull’appartenenza politica e non erano pochi i documenti, ancora in archivio, in cui i sovietici segnalavano il numero dei militari convertiti o potenzialmente sulla via della conversione e gli agenti attivi. Da una nota del libro di Pisarev: <<Situazione al 1° ottobre 1944: (a Tambov) 4522 antifascisti, in particolare tra gli italiani 1700; tra loro attivi 42. Domande per la formazione per la lotta antifascista: tra gli italiani 1940 soldati, di cui 4 sono ufficiali>>. <<Secondo me, però, – sostiene il giornalista di Tambov – sono cifre inventate>>.
La caduta del fascismo, il 25 luglio ’43, e l’8 settembre cambiarono molte delle convinzioni politiche dei nostri prigionieri. Il problema era, come scrive Carlo Vicentini in un suo libro, che <<non bastava essere antifascisti, bisognava essere comunisti>>. <<I contrari – aggiunge Vicentini al telefono – venivano isolati dall’Nkvd. A parte i capi, i commissari politici italiani erano dei poveracci. Spesso erano reduci della guerra di Spagna. Erano gli unici che parlavano l’italiano ed avevano il compito di fare propaganda. All’epoca del fascismo noi non sapevamo niente di cosa avvenisse al di fuori nel mondo. I sovietici non ci dovevano, però, obbligare a cambiare idea>>. A volte avvenivano lunghi interrogatori e nei campi era segnalata la presenza di delatori fra i nostri militari.
I soldati vennero rimpatriati alla fine del ’45, mentre gli ufficiali, per ragioni politiche, ben dopo lo svolgimento del referendum del giugno ’46. L’opinione pubblica italiana era rimasta scossa dai racconti sulla prigionia in Urss dei primi sopravvissuti arrivati in Patria. Gli ultimi 28, rei non si di che cosa, furono liberati soltanto nell’inverno ’54.
Giuseppe D’Amato
Vedi anche:
* Nikolajewka: la tragedia del Don
* DonItalia
* Museo del Medio Don – Rossosch
—

|
 |
Russia: Un giovane Presidente – 2008
22 Aug 2009La Russia volta pagina nella continuità. Il delfino di Vladimir Putin, Dmitrij Medvedev, è il nuovo capo del Cremlino. L’affermazione è stata nettissima come nelle previsioni. Del resto Vizir non aveva alcun vero avversario.
 Che il passaggio di potere nell’ex superpotenza sarebbe stato ridotto a pochi invitati era nella logica degli ultimi eventi. Mosca era impaurita da rivoluzioni sullo stile ucraino e georgiano, importate dall’Occidente, alcune delle quali con nascosti interessi geopolitici stranieri. Questa la spiegazione ufficiale, invero non priva di fondamento. L’eccesso di zelo ed il non voler salvare nemmeno le apparenze hanno disorientato e non poco. Nel ’96 e nel 2000, quando si temette il ritorno del comunismo, le cose andarono diversamente.
Che il passaggio di potere nell’ex superpotenza sarebbe stato ridotto a pochi invitati era nella logica degli ultimi eventi. Mosca era impaurita da rivoluzioni sullo stile ucraino e georgiano, importate dall’Occidente, alcune delle quali con nascosti interessi geopolitici stranieri. Questa la spiegazione ufficiale, invero non priva di fondamento. L’eccesso di zelo ed il non voler salvare nemmeno le apparenze hanno disorientato e non poco. Nel ’96 e nel 2000, quando si temette il ritorno del comunismo, le cose andarono diversamente.
La Russia, per sua natura, vive ponendosi degli obiettivi strategici: negli anni Novanta Boris Eltsin fondò il sistema democratico in un Paese da sempre nelle mani delle autocrazie e delle dittature di turno; nel quadriennio successivo Vladimir Putin ebbe il gravoso incarico di mantenere intatta la Federazione, attaccata dal terrorismo, ed intaccata dal separatismo interno; quindi fu la volta della rinascita economica e di un rinnovato peso sulla scena internazionale.
Da oggi e per i prossimi quattro anni, la linea strategica da perseguire è nuova e pone, dopo secoli, il cittadino al centro dei pensieri del potere. Il miglioramento della qualità della vita dei russi è un’urgenza non più rimandabile in un Paese – attanagliato da una spaventosa crisi demografica – che perde ogni anno circa 700mila abitanti. La creazione di infrastrutture è il secondo compito, vitale per la crescita e lo sviluppo. Anche perché le vacche grasse stanno per finire. I tanti nodi, soprattutto sociali, rimasti nascosti dal boom economico sono destinati a venire ora al pettine.
Dmitrij Medvedev, fin dal 2005, è stato il responsabile dei quattro grandi Progetti nazionali di rinnovamento. Ecco in parte spiegata la sua scelta e non il semplice premio per essere stato un fedele compagno ed esecutore dei disegni di Putin per 17 anni.
Quando c’è la Patria di mezzo i russi sono estremamente pragmatici e non disponibili a giochetti. Eltsin si affidò ad uno sconosciuto ex agente del Kgb, ma dalle mille energie e dalle innate capacità, pur di raggiungere obiettivi, che sembravano allora delle chimere. I risultati ottenuti gli hanno dato ragione anche se si sono registrati grossi passi indietro su conquiste considerate ormai certe.
Il 42enne Medvedev appartiene alla generazione di chi ha conosciuto l’Urss, già da adulto, solo con la perestrojka gorbacioviana e non ne è un nostalgico. E’ un nuovo russo, fattosi col lavoro duro, amante delle comodità e della tecnologia. Insomma una persona con esperienze diverse da quelle di Putin.
Il neo-presidente avrà anche il compito non facile di riportare il suo Paese all’interno della Comunità che conta, strappandolo all’isolamento in cui è caduto nell’ultimo biennio. Gli Stati Uniti e l’Europa sperano che Mosca ritrovi la strada intrapresa da Eltsin e mostri che alcuni “valori” rimangono “comuni”. Se, invece, proseguirà la politica della “potenza” non è lecito attendersi alcunché di buono per il Vecchio Continente e la Russia verrà isolata sempre più verso Est e risucchiata dalla Cina.
Marzo – Maggio 2008
Polonia: un Presidente euroscettico – 2005
19 Aug 2009 Intervista al presidente Lech Kaczyński – Ottobre 2005
Intervista al presidente Lech Kaczyński – Ottobre 2005
Varsavia. Lech Kaczyński ed il gemello Jarosław sono stati innegabilmente i due grandi personaggi di questa interminabile tornata elettorale polacca, iniziata con le legislative del 25 settembre e proseguite con il primo turno delle presidenziali il 9 ottobre scorso. I due fratelli conservatori hanno sbaragliato completamente la concorrenza.
Il più giovane – essendo nato 45 minuti dopo – è stato eletto capo dello Stato al ballottaggio del 23 ottobre contro il liberale Donald Tusk in uno scontro tutto in famiglia fra eredi di Solidarność, mentre il maggiore si è imposto alle parlamentari, ma ha rinunciato alla carica di primo ministro a favore del semisconosciuto economista Kazimierz Marcinkiewicz. “Due fratelli Kaczyński al potere sono troppo per la Polonia”, hanno dichiarato di comune accordo.
Chi ha lavorato con loro ha confidato che anche dopo anni è difficile riconoscerli. Lech è sposato ed ha una figlia, Jarosław invece non ha legami familiari. La loro carriera si è svolta all’ombra di Lech Walesa, che, tuttavia, ha appoggiato Donald Tusk insieme al presidente uscente Aleksandr Kwaśniewski.
“Non è vero che mi hanno votato soprattutto nelle province e nelle zone rurali – dice il neoleader polacco -. E’ un mito! Ampie fasce della società sono preoccupate dell’economia di mercato. Cambieremo questo atteggiamento. Tuttavia, non si può nemmeno negare che Donald Tusk abbia ottenuto considerevoli consensi nelle grandi città”1.
Quale sarà la prima decisione che prenderà da presidente della Polonia? “Prima di tutto sarà necessario che mi prenda un piccolo periodo di riposo”2.
In alcuni ambienti di Bruxelles Lei è stato descritto come un euroscettico. Quale è la sua posizione sui rapporti con l’Unione europea? “Sono contrario alla Costituzione Ue, ma sono stato favorevole all’adesione del mio Paese all’Unione europea, avvenuta il primo maggio 2004”3.
A Varsavia si fa un gran parlare della cosiddetta “Dimensione orientale”, ossia la politica estera da portare avanti nei confronti dei Paesi vicini ex sovietici. “Le ripeto. Sono per la piena partecipazione della Polonia all’Ue, ma sono anche per la difesa degli interessi polacchi”4.
A Kiev l’anno scorso, durante la rivoluzione arancione si è registrato quasi uno scontro tra l’Ue e Russia, tra Varsavia e Russia. Cosa succederà sotto la sua presidenza? In Ucraina e Bielorussia si voterà nella prossima primavera. “Per noi è importante definire una politica ferma da avere nei confronti di Mosca. Cerchiamo all’interno dell’Ue dei membri che ci aiutino a portare avanti insieme questo tipo di linea”5.
Giuseppe D’Amato
Interview to Mr. Lech Kaczyński, new Polish president – October 2005
1. “It’s not true that especially people from the countryside and from the provinces voted for me. It’s a myth! Important parts of the Polish society are worried about market economy. We will change this attitude. However, we can’t deny that Donald Tusk has obtained a considerable amount of votes in big towns”.
- “I need a period of rest” (before stepping in as the new president).
- You have been described as an euro-sceptic. “I’m against the EU Constitution, but I was for the entry of Poland to the European Union on May 1st, 2004”.
- “I’m for the complete participation of Poland in EU, but I’m also for the defence of the Polish interests”.
Relationship with Russia? “It’s important for us to establish a firm policy towards Moscow. We are looking for EU members, who may help us to carry on this political line”.
Welcome
We are a group of long experienced European journalists and intellectuals interested in international politics and culture. We would like to exchange our opinion on new Europe and Russia.
Categories
- Breaking News (11)
- CIS (129)
- Climate (2)
- Energy&Economy (115)
- EU Eastern Dimension (85)
- Euro 2012 – Sochi 2014 – World Cup 2018, Sport (43)
- Euro-Integration (135)
- History Culture (198)
- International Policy (261)
- Military (74)
- Interviews (18)
- Italy – Italia – Suisse (47)
- Odd Enough (10)
- Poland and Baltic States (126)
- Religion (31)
- Russia (421)
- Survey (4)
- Turning points (4)
- Ukraine (176)
- Российские страницы (113)
Archives
- November 2020
- October 2020
- September 2020
- August 2020
- July 2020
- May 2020
- April 2020
- March 2020
- January 2020
- December 2019
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- July 2019
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- May 2017
- March 2017
- January 2017
- December 2016
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- July 2016
- June 2016
- May 2016
- April 2016
- February 2016
- January 2016
- November 2015
- October 2015
- September 2015
- June 2015
- April 2015
- March 2015
- February 2015
- January 2015
- December 2014
- November 2014
- October 2014
- September 2014
- August 2014
- July 2014
- June 2014
- May 2014
- April 2014
- March 2014
- February 2014
- January 2014
- December 2013
- November 2013
- October 2013
- September 2013
- August 2013
- July 2013
- June 2013
- May 2013
- April 2013
- March 2013
- February 2013
- January 2013
- December 2012
- November 2012
- October 2012
- September 2012
- August 2012
- July 2012
- June 2012
- May 2012
- April 2012
- March 2012
- February 2012
- January 2012
- December 2011
- November 2011
- October 2011
- September 2011
- August 2011
- July 2011
- June 2011
- May 2011
- April 2011
- March 2011
- February 2011
- January 2011
- December 2010
- November 2010
- October 2010
- September 2010
- August 2010
- July 2010
- June 2010
- May 2010
- April 2010
- March 2010
- February 2010
- January 2010
- December 2009
- November 2009
- October 2009
- September 2009
- August 2009
Our books