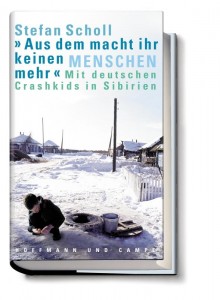All Italiano posts
Il capo dei tatari di Crimea, Gemiliev, premiato in Polonia davanti a Obama ed Hollande.
17 May 2014Mustafà Gemiliev, già candidato al premio Nobel per la pace per il 2014, verrà insignito di un’altissima onorificenza polacca dalle autorità di Varsavia il 3 giugno prossimo. Alla cerimonia è prevista la partecipazione dei presidenti americano Barack Obama e francese Francois Hollande. 
Successivamente il 6 giugno sono in programma le celebrazioni per il 70esimo anniversario dello sbarco alleato in Normandia, dove interverrà il leader russo Vladimir Putin.
Come si ricorderà Mustafà Gemiliev, già dissidente in epoca sovietica, è da decenni il punto di riferimento dei tatari di Crimea (ricoprendo la carica di capo del Medzhlis – il Parlamento tataro – fino al 2013) e da tempo ricopre la carica di deputato della Rada (Parlamento) ucraina.
Da alcune settimane Gemiliev non può rientrare in Crimea dopo un viaggio a Kiev. Dopo che la sua casa nella penisola è stata perquisita dalla polizia, la moglie ha avuto malore ed è stata ricoverata in ospedale.
Le autorità regionali hanno proibito qualsiasi manifestazione in occasione del 70esimo anniversario della deportazione dei tatari di Crimea il 18 maggio. Rinforzi alle forze dell’ordine sono arrivate a Simferopoli ad inizio settimana. Il centro di Simferopoli è fortemente presidiato da forze anti-sommossa. Nel 2013 ex dissidenti, intellettuali e politici, provenienti da mezzo mondo, si riunirono per preparare il 70esimo.
La Crimea fu liberata dalle truppe di occupazione nazi-fasciste il 12 maggio 1944. Sei giorni dopo, altri soldati, questa volta sovietici, entrarono con le armi in pugno nelle case dei tatari. “Muovetevi immediatamente. Vi mandano in un posto speciale”.
La falsa colpa, mai dimostrata, era di aver collaborato col nemico, ma non ci fu mai un processo. In poche ore su carri merci 191mila persone – in maggioranza donne, vecchi e bambini – vennero spediti prevalentemente in Uzbekistan, ma altri finirono nella regione di Kostroma, Mari El, sugli Urali. Circa il 46% di loro morì. Veniva così eseguito l’ordine n.5859 del Comitato statale di Difesa, firmato da Beria e da Stalin.
G.D.A.
Sono le stragi di Odessa e Mariupol, più che il referendum sull’autonomia in Donbass e nella regione di Lugansk, a portare dei cambiamenti in Ucraina orientale. Le due tragedie sono state un volano per far assegnare agli occhi delle disorientate opinioni pubbliche locali punti agli argomenti strombazzati dalla penetrante propaganda televisiva russa. 
Il senso è chiaro e diretto. Primo: a Kiev c’è gente che usa la forza contro il proprio popolo. Secondo: al potere si sono insediati dei “fascisti”, nipoti degli storici nemici dell’Ucraina occidentale. Miglior benzina da buttare sul fuoco della destabilizzazione non poteva essere trovato.
La ragione delle file di elettori durante la consultazione organizzata dai filo-russi è semplice: a Mariupol vi erano in funzione soltanto una decina di seggi per mezzo milione di abitanti; a Donetsk, quasi 50 per un milione. Le liste elettorali sono state un optional.
Ad inizio crisi soltanto il 5% degli ucraini orientali guardava al Cremlino come soluzione per i problemi socio-economici. Adesso sono circa il 30%. I perché di questa brusca salita sono il vuoto di potere e la propaganda russa.
Ignorare la dimostrazione di pensiero di domenica 11 maggio è tuttavia foriero di sventure ed essa va contestualizzata sul piano interno e non su quello geopolitico internazionale in presenza di una posizione di attesa del Cremlino.
Capire chi sta dietro alla Repubblica popolare di Donetsk aiuta a comprendere cosa sta realmente succedendo. Il suo principale finanziatore è il presidente deposto Viktor Janukovich, riparato nella vicina Rostov, che del Donbass è stato a lungo governatore, poi referente politico. Contraddittorio è il comportamento del suo tradizionale sponsor Rinat Akhmetov, che guida un gruppo da 300mila persone, con interessi sia in Russia che in Europa. Infatti è per un’Ucraina unita, ma con l’Est fortemente autonomo da Kiev.
Secondo il politologo Taran, se prima Janukovich e Akhmetov agivano insieme, “adesso ognuno di loro ha un suo obiettivo”. Il primo potrebbe voler tornare in Patria come leader di un nuovo Stato. Il secondo, pare, non essere d’accordo ed avrebbe appena scelto Julija Timoshenko, come candidato per le presidenziali ucraine del 25 maggio.
Il favoritissimo magnate Poroshenko appartiene al gruppo rivale, radunatosi intorno agli oligarchi Firtash ed Kolomojskij. Quest’ultimo, governatore di Dnepropetrovsk, è la “stella” nascente. Si è inventato un modello per “contenere” i filo-russi con milizie locali.
A Mariupol, i separatisti hanno assaltato, distruggendola, la filiale della sua “Privatbank”. Dopo pochi giorni la Guardia nazionale di Dnepropetrovsk ha riportato l’ordine sul mare d’Azov, ma 7 persone sono morte negli scontri. Quindi sono uscite in strada le ronde, composte da lavoratori della locale mega-azienda di Akhmetov, indirettamente a difesa del secondo porto del Paese, da cui transita grano e l’acciaio esportato.
Ad Odessa, invece, i disordini del 2 maggio hanno fatto saltare il locale governatore-magnate, Vladimir Nemirovskij, vicino al premier Jatseniuk, che, prima di andarsene, ha denunciato come mandanti della tragedia al palazzo dei Sindacati gente vicina alla Timoshenko. Al suo posto è stato scelto Igor Palitsa, “braccio destro” – guarda caso – di Kolomojskij.
In conclusione, i “Paperoni” in dollari e grivne, insigniti da Kiev della carica di governatori dopo la fine del Majdan per mantenere insieme l’Ucraina, stanno sfruttando questa crisi per saldare conti in sospeso tra loro.
Il risultato può essere alla fine la “somalizzazione” della repubblica ex sovietica.
Giuseppe D’Amato
Crimea. Mamchur, il nuovo eroe di Ucraina.
26 Mar 2014 Lui ci ha messo la faccia dimostrando un coraggio fuori dal comune, mentre gli altri – i suoi avversari – sono andati in giro mascherati o peggio i suoi superiori si sono nascosti a Kiev in una versione locale del nostro “8 settembre”. Il colonnello Julij Mamchur passerà alle storia di questa terribile pagina nei rapporti russo-ucraini come l’esempio di rettitudine da seguire, l’uomo che ha mantenuto il giuramento di servizio alla sua Patria. 
Il mondo l’ha conosciuto il 4 marzo scorso, quando ha portato i suoi sottoposti a marciare contro le unità speciali russe, che avevano occupato l’aeroporto di Belbek ad una ventina di chilometri da Sebastopoli. Le telecamere hanno immortalato la scena di queste centinaia di uomini disarmati, che cantavano l’inno nazionale, con in testa la bandiera sovietica da combattimento della Seconda guerra mondiale, quella ucraina ed il loro comandante. I russi sparavano per aria ed urlavano che avrebbero mirato alle gambe.
“Non ho avuto paura”, ha sempre detto il 42enne colonnello Mamchur che, in quei frangenti concitati, invitava i suoi uomini a stare tranquilli sotto alle raffiche di mitra e questi urlavano bestemmie ed invitavano i russi a sparare loro addosso.
“Vogliamo negoziare, chiamate i vostri comandanti”, sono state le parole del carismatico capo della 204esima Brigata tattica di aviazione, una volta arrivato a non più di un paio di metri per guardare negli occhi i suoi potenziali nemici, che hanno immediatamente chiesto per radio cosa fare.
Da quel momento Mamchur ha imbrigliato i russi per 18 giorni ed è diventato l’orgoglio di un Paese, l’eroe da ammirare.
Crisi di Crimea: Dove va l’Ucraina.
23 Mar 2014Dalla crisi in Crimea nasce il Vecchio Continente del 21esimo secolo: l’Ucraina di fatto entra in Ue e lo “scenario morbido” del post crollo dell’Urss, con le repubbliche ex sovietiche unite nella Csi, viene abbandonato.
Siamo di fronte non solo ad un brusco cambiamento degli equilibri geostrategici, imperanti negli ultimi due decenni, ma anche allo sgretolamento del mondo slavo orientale.
Dopo 360 anni di storia comune il divorzio dell’Ucraina con la Russia è ormai consumato e lo “Stato fuori dai blocchi, ponte tra Est ed Ovest”, voluto dal deposto presidente Viktor Janukovich, è un ricordo sbiadito. 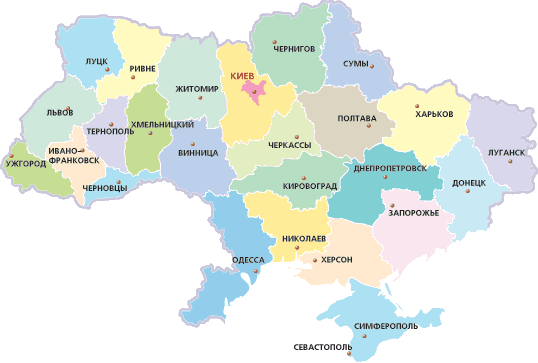
Le nuove autorità di Kiev hanno firmato il capitolato “politico” del patto di Associazione economica con l’Unione europea, causa prima del moto di protesta che ha generato l’“EuroMaidan” e, per reazione, la conseguente annessione da parte di Mosca della Crimea (regione russa, “regalata” all’Ucraina da Krusciov nel 1954, a suggello dei 3 secoli di amicizia tra i due popoli slavi orientali).
Ufficialmente il Cremlino si opponeva a tale accordo, giustificandosi con future possibili difficoltà commerciali tra le due repubbliche ex sovietiche. In realtà il problema era di altro genere: avvicinandosi così tanto all’Ue, Kiev avrebbe fatto saltare la nascita di una specie di “mini-Urss economica” voluta da Putin entro il 2015.
Alla vigilia della firma di Bruxelles l’Ucraina ha rinunciato alla presidenza di turno della Csi, la comunità sorta dalle ceneri dell’Urss, ed anzi, come la Georgia dopo la guerra con Mosca nell’agosto 2008, ha scelto di ritirare la sua adesione all’organizzazione.
L’obiettivo di Kiev, è inutile nasconderlo, è quello di una piena entrata come membro effettivo nell’Unione europea. Nel 2007 l’Ucraina faceva fatica a comprendere perché Bruxelles avesse accettato Bulgaria e Romania, Paesi di simili complessità economica ed ambientale, ma strategicamente meno importanti soprattutto dal punto di vista energetico.
Ed a questo punto, dopo quello che è avvenuto in Crimea, altro scenario non è ipotizzabile. Serviranno pertanto marce forzate ed imponenti investimenti europei ed americani. L’aspetto politico è il meno preoccupante: a parte le baltiche, l’Ucraina è l’unica repubblica ex sovietica dove veramente ha attecchito la democrazia. Difficilissimo è invece quello economico-finanziario.
Stando agli ultimi calcoli è necessario una specie di “piano Marshall”, circa 70-80 miliardi di euro, nel medio termine per ammodernare il tessuto industriale ucraino, troppo vecchio per concorrere in Ue e troppo dipendente dalla Russia. Da 3 a 7 miliardi sono solo da destinare ai gasdotti costruiti in epoca sovietica.
Tutta questa pioggia di soldi dovranno essere investiti con lo scopo di portare l’Ucraina al livello della Polonia odierna.
Ed in ultimo. L’attuale partita geostrategica costringerà i membri dell’Ue a muoversi una volta tanto insieme. A Kiev, forse, è anche nata una politica estera comune.
Gda
Cosa è successo a Kiev? Nulla di inatteso, purtroppo. Sono stati gli estremisti, rimasti fuori dalla trattativa politica parlamentare, ad aver soffiato sul fuoco della protesta violenta e ad aver provocato gli scontri.
Le opposizioni sono formate da un fronte composito di forze eterogenee, alcune delle quali lontane ideologicamente fra loro.
Ufficialmente sono tre i leader politici: Arsenij Jatseniuk del partito “Patria” (quello dell’ex premier Julija Timoshenko), l’ex pugile Vitalij Klitschko capo di Udar, ed Oleg Tjagnibok responsabile dei nazionalisti “Svoboda”.
Sono loro ad avere imbastito il negoziato con il presidente Viktor Janukovich a nome del “Maidan”, che, in realtà, nelle sue prime settimane è stato un movimento spontaneo di protesta popolare della società civile ucraina.
In una seconda fase, col passare dei giorni e l’aumento del numero della barricate, si sono aggiunti i movimenti legati all’estremismo ultranazionalista, come l’ormai famoso “Settore di destra”. Questi radicali, che si vedono come i difensori della nazione ucraina e non lottano affatto per l’integrazione europea come i liberal-riformisti, hanno preso il controllo delle operazioni di “difesa del Maidan”.
La politica li ha esclusi dal tavolo delle trattative, nonostante essi abbiano tentato di avere una loro rappresentanza. Il loro unico obiettivo è la rimozione del presidente Janukovich, non i mutamenti costituzionali. E adesso sarà difficile farli sgombrare dal Maidan.
I radicali extraparlamentari, insieme ai delusi del movimento (che sono tanti!), si sono resi conto che il capo dello Stato tentava di allungare nei tempi il più possibile la partita negoziale alla Rada, per potere arrivare a giocare le sue carte alle prossime presidenziali previste per il marzo 2015, ma ora anticipate di tre mesi.
Le opposizioni sono in minoranza in Parlamento, dove sono troppo spesso apparse non in grado di prendere l’iniziativa. Ecco, quindi, la ragione per la quale i radicali hanno utilizzato la forza e la violenza per provocare concessioni da parte di Janukovich.
Che la situazione politica a Kiev sia estremamente complessa lo dimostra il fatto che la cancelliera tedesca Merkel abbia invitato a Berlino per consultazioni, lunedì 17, i soli Jatseniuk e Klitschko, escludendo Tjagnibok, considerato da fonti polacche troppo vicino a forze vetero-fasciste.
Parallelamente si gioca la partita geostrategica. La Russia ha messo sul tavolo gli aiuti finanziari necessari a salvare l’Ucraina dalla bancarotta. L’Unione europea non intende spendere nemmeno un euro.
Mosca ha già consegnato a Kiev 3 miliardi di dollari. Bruxelles ha solo tentato di scongelare invano presso il Fondo monetario internazionale un vecchio prestito agli ucraini bloccato dal 2011.
I catastrofici errori della diplomazia continentale sono sotto gli occhi di tutti e rischiano di spaccare in due l’ex repubblica sovietica. In questi giorni il suo destino come Stato unitario, uscito dal crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, è fortemente messo in dubbio.
gda
Ucraina, rischi secessione.
21 Feb 2014“Non tutti hanno fiducia nei leader politici della protesta”. Così il politologo Vadim Karasiov, direttore dell’Istituto di strategia globale di Kiev.
“Mi riferisco ai vari Klitschko e Jatseniuk, – continua il noto politologo ucraino -. Il loro seguito è limitato. I giovani, quelli con sentimenti più radicali, non credono in loro. Gli obiettivi di questi ultimi sono la distruzione del partito delle Regioni e le dimissioni di Janukovich”. 
Come si può fermare il bagno di sangue? “E’ necessario capire che bisogna lasciare da parte il linguaggio degli ultimatum, i giochi tattici e gli imbrogli. Serve al più presto un compromesso per salvare il Paese. La gente non crede più a questa classe politica”.
Ma chi controlla i radicali? “La situazione è sfuggita di mano alla politica”.
Cosa vogliono i giovani del Maidan o perlomeno alcuni suoi settori, visto l’eterogeneità delle cosiddette opposizioni? “I giovani pretendono cose impossibili, cose fuori dalla realtà, come il movimento di protesta in Francia del maggio 1968. Qui sul nostro Maidan vi è una sintesi di tutte quelle correnti da Tahrir de Il Cairo ad i vari ‘occupy’. Si sono unite forme di protesta di carattere arabo, europeo con la tradizione ucraina dell’amore per la libertà. Sia per Janukovich che per le opposizioni è difficile controllare questa gente”.
Chi sostiene Janukovich? “La Russia, il clan di Donetsk, numerosi oligarchi, circa il 20% degli elettori ucraini. I dati dei sondaggi sono chiari: il 50% della popolazione sostiene il Maidan (e sono quasi tutti ad Ovest); il 50% no (e sono ad Est). A Kiev non c’è un tiranno come in Tunisia od un Ceausescu come in Romania. L’Ovest del Paese sostiene il Maidan, perché non crede all’Est”.
Ma perché Janukovich non ha fatto sgomberare piazza Indipendenza? “Avrebbe rischiato uno spaventoso spargimento di sangue con migliaia di morti. Il presidente non vuole entrare nella storia come un tiranno sanguinario. Il Maidan poi non è piazza Tienanmen. Siamo sotto agli occhi dell’Europa!”.
Quali errori ha compiuto l’Europa? “Non ha capito la situazione in cui si trovava l’Ucraina alla vigilia della firma del patto di Associazione all’Ue. Per un Paese di 46 milioni di persone e con un’economia così complessa si doveva pensare subito ad un’adesione per difenderla da Mosca. Sostenendo le opposizioni, l’Ue ha trasformato una questione interna in uno scontro geopolitico. E poi manca un centro unico diplomatico. Quale è la linea comune? Si sentono dei cori in cui ognuno canta per proprio conto”.
Come andrà a finire la crisi? “La crisi sarà ancora lunga. In ballo vi è la stessa sopravvivenza dello Stato ucraino. Alla fine potrebbero emergere due Stati, uno ad est e l’altro all’ovest. Speriamo che non si ripeta in tal caso lo scenario jugoslavo, ma sia un divorzio alla cecoslovacca”.
Sochi 2014, Le Olimpiadi della sicurezza.
7 Feb 2014“Saranno Giochi memorabili”. Così Dmitrij Cernyshenko, presidente del Comitato organizzatore ‘Sochi 2014’. In attesa delle imprese sportive degli atleti, questa edizione invernale in riva al mar Nero è di certo già ineguagliabile per le spese astronomiche (51 miliardi di dollari) e per le incredibili misure di sicurezza. Roba da far impallidire le altrettanto problematiche Olimpiadi di Pechino 2008 e di Londra 2012!
La regione, dove si terranno le competizioni, è stata trasformata, dal 7 gennaio alla fine di marzo, in una specie di fortezza inespugnabile. Dallo spazio i satelliti scrutano 24 ore su 24 le strade della città rivierasca e i campi di gara in alta montagna. 
A terra sono attivi sistemi anti-missilistici modernissimi (Pantsir-S) (utilizzabili contro jet impazziti, vedi 11 settembre), un centinaio di droni (pronti per il decollo) e marchingegni elettronici per il controllo delle comunicazione così sofisticati che il dipartimento di Stato Usa ha invitato i propri concittadini a lasciare a casa smartphone e portatili se non si vuole venire intercettati.
Organizzare le Olimpiadi ad un tiro di schioppo dal Caucaso settentrionale non è stata, forse, una buona idea, ma nel 2007 Vladimir Putin voleva dimostrare che la Russia meridionale è stata pacificata. Le minacce degli estremisti in estate e i recenti attentati dinamitardi di Volgogrado aumentano la preoccupazione del Cremlino e degli stranieri.
Trentamila poliziotti ed uomini delle forze dell’ordine (quasi il doppio che a Londra) sono impegnati nei classici controlli di routine. A loro si aggiungeranno durante le giornate delle gare migliaia di volontari, come è tradizione in ogni Olimpiade.
Atleti, giornalisti e tifosi sono stati avvertiti per tempo: senza passaporto e badge relativo al seguito o biglietti non si va da nessuna parte. Tante sono le aree chiuse o meglio dire “rosse” o “proibite”. I servizi segreti hanno svolto un lavoro preventivo, controllando le identità di chiunque abbia fatto richiesta di vedere o partecipare dal vivo ai Giochi. Nulla, a quanto è affermato ufficialmente, è stato lasciato al caso.
Così, dal 31 dicembre scorso, è stato sospeso il servizio di consegna dei pacchi postali nella regione olimpica. Le automobili, che non hanno la targa di Sochi o non hanno ottenuto speciali accrediti, non possono entrare in città. Devono essere lasciate in appositi parcheggi: i più vicini si trovano a circa cento chilometri.
A Sochi i tombini sono stati sigillati, mentre la polizia ha ispezionato casa per casa. I 350mila abitanti del centro rivierasco sono stati invitati a pulire i balconi, a non stendere i panni e ad essere gentili con gli stranieri.
In epoca sovietica, a Mosca 1980, i possibili “disturbatori” vennero mandati fuori città. Adesso, per lenire le critiche occidentali, Putin ha ammorbidito il suo decreto, permettendo “manifestazioni di protesta” limitate dopo accordi con le autorità. Lo stesso avvenne a Pechino, ma la trafila burocratica imposta evitò qualsiasi dimostrazione di dissenso.
Servirà tutto questo dispiegamento di forze contro il vero pericolo, ossia terroristi-kamikaze solitari? La speranza dice di sì..
I Giochi olimpici di Sochi 2014 sono la vetrina della nuova Russia post sovietica, l’evento costruito su misura per ostentare la resurrezione dell’ex superpotenza dopo il crollo dell’Urss e per lanciare il chiaro messaggio geostrategico che con il Cremlino bisognerà fare i conti anche nel XXI secolo. 
L’edizione invernale sul mar Nero ha ulteriori due caratteristiche. La prima è di carattere politico-personale, ossia i Giochi sono il culmine e l’elogio massimo del potere di Vladimir Putin, l’uomo della rinascita e dell’arricchimento del gigante slavo.
La seconda è di carattere ludico. Sochi 2014 è l’occasione per ospitare finalmente Olimpiadi, pienamente tali, che metteranno la Russia per due settimane al centro dello sport mondiale e le daranno lustro per decenni.
Il russo medio è ancora dispiaciuto per il boicottaggio occidentale a Mosca 1980, con il conseguente fallimento di quella edizione. In epoca sovietica l’organizzazione delle Spartachiadi aveva già dimostrato l’attrazione del Paese slavo verso le competizioni internazionali.
In quest’ultimo aspetto non c’è nulla di male. L’importante, però, è che le vittorie negli stadi non servano da combustibile per l’ennesima bieca ondata di nazionalismo e di xenofobia. Gli ultimi, in ordine di tempo, fatti di sangue sono un preoccupante campanello d’allarme.
Certe follie mettono in pericolo le stesse fondamenta della convivenza tra un centinaio di etnie russofone diverse, appartenenti a differenti confessioni religiose fra loro, e l’ospitalità nei confronti di ex “fratelli sovietici”.
A differenza di quanto potrebbe in apparenza sembrare, Sochi 2014 non è un’Olimpiade di popolo, come era stata – con tutti i suoi limiti – Mosca 1980. I turisti nazionali ed anche quelli stranieri paiono degli intrusi ad una festa altrui, degli ignari spettatori di un programma, il cui canovaccio è già stato scritto. Semplificazioni per i visti non ve ne sono state né tantomeno sono pronte strutture alberghiere alla portata dei portafogli meno pieni di banconote.
L’edizione sul mar Nero è prettamente un evento mediatico, facile da controllare per evitare sorprese.
Giuseppe D’Amato
La scelta degli strateghi della tensione non è affatto casuale. Primo: insieme a Rostov sul Don, Volgogrado è uno strategico crocevia ferroviario ed autostradale. Non è un caso che, durante la Seconda guerra mondiale, Hitler avesse inviato le proprie forze migliori per conquistare questa città, allora denominata Stalingrado, nodo di collegamento tra il Caucaso settentrionale e la steppa. 
Secondo: i terroristi colpiscono duramente il sempre più aggressivo nazionalismo russo, che utilizza la vittoria di settanta anni fa in riva al Volga per cementare le proprie fondamenta. Terzo: i mandanti dell’attentato inviano un chiaro avvertimento al Cremlino. Ossia “possiamo beccarvi anche fuori dal Caucaso, dove vogliamo”.
Quarto: i terroristi seminano il panico tra la popolazione come nel tragico autunno 1999 al tempo del passaggio di poteri tra Eltsin e Putin. Per lunghe ore gli inquirenti federali ci hanno raccontato che le ultime azioni terroristiche sono state opera dalle solite disperate “vedove – kamikaze” dalla capigliatura scura, che vanno in giro coperte dai veli. Insomma gente facilmente riconoscibile.
Ora viene fuori che gli attentatori erano in realtà uomini con la fisionomia slava. La notizia, non più celabile, ha portato scompiglio. Il nemico si annida fra noi, è oggi il pensiero del russo medio.
Il rischio palese è che, comunque, si levi una nuova ondata xenofoba anti-straniero o anti-tutto quello che non sia evidentemente slavo. Nei mesi scorsi dalle complesse province essa ha addirittura raggiunto Mosca con uno spaventoso assalto contro gli insediamenti dei caucasici e degli asiatici in un quartiere periferico della capitale.
Ma l’obiettivo vero della presente strategia della tensione è stato dichiarato nell’estate scorsa da uno dei capi degli estremisti, Doku Umarov. I terroristi intendono far andare di traverso al presidente Vladimir Putin le Olimpiadi invernali di Sochi, in programma dal 7 febbraio prossimo. Questi giochi sportivi sono considerati dai nemici del Cremlino come la “vetrina del regime”.
L’attenzione del mondo intero si concentrerà in quelle due settimane sulla Russia. Un’occasione migliore per dimostrare che il separatismo ed il radicalismo sono ancora vivi, dopo le pesanti sconfitte degli ultimi anni, non potrebbe esserci.
Putin ne è ben conscio. Questa è la ragione delle incredibili misure di sicurezza che atleti, tifosi ed addetti ai lavori dovranno sottoporsi a Sochi. Interminabili ore di coda per il controllo documenti serviranno per raggiungere la sede delle gare. Secondo alcune indiscrezioni vi sarà un poliziotto ogni due visitatori. All’apparenza le prossime Olimpiadi invernali non paiono essere granché una festa. .
Nelle ultime due settimane Vladimir Putin ha mostrato il suo volto migliore, quello di leader illuminato, liberando i cosiddetti “prigionieri politici”, tra cui l’odiatissimo oligarca Khodorkovskij.
Adesso, a Volgogrado, i terroristi gli rispondono a modo loro, provocandolo. Vogliono che lo “zar buono” dei russi tiri fuori gli artigli.
gda
Russia: i misteri dell’amnistia.
30 Dec 2013Il potere dei Giochi olimpici! In un colpo solo Vladimir Putin elimina tutti i problemi connessi con i “prigionieri politici”, come vengono chiamati dall’opposizione i vari Khodorkovsky, Pussy Riots, i manifestanti anti-Cremlino del Bolotnoe del maggio 2012. 
Nemmeno il più bravo analista del leader russo avrebbe potuto immaginare scelte tanto audaci.
La dinamica della liberazione di Michail Khodorkovsky è roba da gialli sulle spie della Guerra Fredda. Nell’arco di meno di ventiquattro ore dall’annuncio della grazia concessa dal Cremlino, l’ex oligarca è stato di fatto sparire dalla colonia penale in Carelia, mentre decine di giornalisti lo attendevano all’esterno. Poi, con in mano il passaporto per l’estero – con tanto di visto tedesco sopra -, è stato messo di corsa su un aeroplano e spedito, come fanno di solito i bravi figli, dalla mamma ammalata.
Tanti, forse troppi, sono i misteri che avvolgono questo clamoroso “lieto fine” nel giorno in cui la Russia celebra la giornata dei “cecchisti”, ossia degli uomini dei “servizi”, l’ex Kgb. Il primo: Khodorkovsky ha scritto la lettera per la grazia in piena libertà? Il secondo: quali sono le vere condizioni per il rilascio? Il terzo: è vero che le autorità giudiziarie avevano nuovi documenti per iniziare il terzo procedimento contro di lui?
L’averlo messo su un aereo e mandato all’estero significa che l’ex oligarca probabilmente non tornerà più in Patria a breve. Putin non vuole farsi rubare la scena proprio ora.
Adesso che al Cremlino intonano la versione nazionale della canzone napoletana “Chi ha avuto, ha avuto! Scordiamoci il passato”, come si fa ad accusare Putin di essere un autocrate, se non un “tiranno” come gridava l’opposizione in piazza soltanto venti mesi fa?
L’ex ufficiale del Kgb indossa oggi i panni dello “zar illuminato”, del “padre buono” che protegge la sua famiglia dai pericoli della società moderna, dai valori non tradizionali in arrivo dall’Occidente.
E con questi panni, freschi di lavanderia, si appresta a fare le veci del padrone di casa all’edizione invernale dei Giochi olimpici, un evento atteso in Russia da decenni. Il precedente moscovita del 1980, con il boicottaggio occidentale per l’intervento in Afghanistan ai tempi di Brezhnev, brucia ancora sulla pelle delle generazioni più anziane.
Ecco la ragione di tali scelte sullo scenario interno, associate con il rilancio dell’immagine del Paese sulla scena internazionale: leggasi Siria, Iran, Ucraina.
A Mosca i dissidenti e l’opposizione sono contenti per la fine dei tanti casi “politici”, Khodorkovsky su tutti.
Welcome
We are a group of long experienced European journalists and intellectuals interested in international politics and culture. We would like to exchange our opinion on new Europe and Russia.
Categories
- Breaking News (11)
- CIS (129)
- Climate (2)
- Energy&Economy (115)
- EU Eastern Dimension (85)
- Euro 2012 – Sochi 2014 – World Cup 2018, Sport (43)
- Euro-Integration (135)
- History Culture (198)
- International Policy (261)
- Military (74)
- Interviews (18)
- Italy – Italia – Suisse (47)
- Odd Enough (10)
- Poland and Baltic States (126)
- Religion (31)
- Russia (421)
- Survey (4)
- Turning points (4)
- Ukraine (176)
- Российские страницы (113)
Archives
- November 2020
- October 2020
- September 2020
- August 2020
- July 2020
- May 2020
- April 2020
- March 2020
- January 2020
- December 2019
- November 2019
- October 2019
- September 2019
- August 2019
- July 2019
- June 2019
- May 2019
- April 2019
- March 2019
- February 2019
- December 2018
- November 2018
- October 2018
- September 2018
- August 2018
- July 2018
- June 2018
- May 2018
- April 2018
- March 2018
- February 2018
- January 2018
- December 2017
- November 2017
- October 2017
- September 2017
- August 2017
- July 2017
- May 2017
- March 2017
- January 2017
- December 2016
- November 2016
- October 2016
- September 2016
- July 2016
- June 2016
- May 2016
- April 2016
- February 2016
- January 2016
- November 2015
- October 2015
- September 2015
- June 2015
- April 2015
- March 2015
- February 2015
- January 2015
- December 2014
- November 2014
- October 2014
- September 2014
- August 2014
- July 2014
- June 2014
- May 2014
- April 2014
- March 2014
- February 2014
- January 2014
- December 2013
- November 2013
- October 2013
- September 2013
- August 2013
- July 2013
- June 2013
- May 2013
- April 2013
- March 2013
- February 2013
- January 2013
- December 2012
- November 2012
- October 2012
- September 2012
- August 2012
- July 2012
- June 2012
- May 2012
- April 2012
- March 2012
- February 2012
- January 2012
- December 2011
- November 2011
- October 2011
- September 2011
- August 2011
- July 2011
- June 2011
- May 2011
- April 2011
- March 2011
- February 2011
- January 2011
- December 2010
- November 2010
- October 2010
- September 2010
- August 2010
- July 2010
- June 2010
- May 2010
- April 2010
- March 2010
- February 2010
- January 2010
- December 2009
- November 2009
- October 2009
- September 2009
- August 2009
Our books